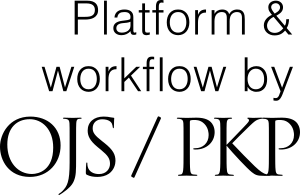Archivio
-

LA GUERRA IN UCRAINA: BILANCIO E PROSPETTIVE
N. 17 (2022)L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin ha acceso un fervente dibattito su temi che in Italia sovente trovano poco spazio al di fuori dell’accademia e di ambienti specializzati. Le relazioni internazionali e l’analisi militare hanno fatto breccia nei salotti televisivi diventando moneta corrente del dibattito mediatico e del discorso pubblico italiani.
Cercare di orientarsi tra opinioni e analisi non è semplice, a maggior ragione in un contesto caratterizzato da dinamiche estremamente articolate e fluide. A poco più di un mese dall’inizio dell’offensiva russa è però possibile fare il punto su alcuni aspetti chiave del conflitto in corso, e delinearne qualche possibile prospettiva. È proprio questo lo scopo di questo numero di Human Security interamente dedicato alla guerra in Ucraina.
In apertura, Anna Caffarena e Gabriele Natalizia – entrambi docenti di Relazioni Internazionali – introducono il lettore ad alcuni dei modelli teorici più influenti delle Relazioni Internazionali. Caffarena riflette sulle tesi proposte dallo studioso John Mearsheimer, evidenziando come tentare di comprendere il comportamento russo a partire da un solo elemento, il presunto allargamento della NATO, porti a un’interpretazione limita e limitante delle relazioni internazionali che, in ultima analisi, non è in grado di spiegare gli eventi tragici a cui stiamo assistendo. Segue Natalizia che ricorre alle “tre immagini” (individuo, stato e sistema internazionale) elaborate dallo studioso Kenneth Waltz per comprendere perché il Cremlino abbia deciso di scatenare il conflitto armato proprio ora e perché il presidente Putin sembra essersi dimostrato un calcolatore meno abile che in passato.
Al netto di possibili errori di calcolo strategico, quali sono le ragioni del fallimento della guerra lampo tentata ma fallita da Putin? Perché, nonostante i suoi grandi numeri, l’apparato militare russo sta faticando a raggiungere i propri obiettivi? Queste sono le domande al centro delle analisi proposte dagli autori dei due articoli successivi che, insieme, rappresentano un approfondimento sulla performance della macchina militare russa. Da un lato, un senior security analyst, con un background di attività in ambito Nazioni Unite, si concentra sui fattori dirimenti per il successo delle guerre lampo, evidenziando alcune delle principali carenze russe; dall’altro, Stefano Ruzza – docente di Scienze Politiche e di Peace and Conflict Studies – disseziona la logistica militare russa per osservarne i deficit e avanzare elementi di analisi rilevanti per cogliere le prospettive di più lungo termine del conflitto.
Gli ultimi due articoli di questo numero di Human Security riportano il focus sullo scenario internazionale. Jean-Marie Reure, intern presso il Peace Research Institute Frankfurt, si interroga sul futuro delle capacità di proiezione russa a livello globale, approfondendo il tema delle operazioni ibride della dottrina Primakov-Gerasimov e il ruolo degli (pseudo-)contractor del famigerato gruppo Wagner. In ultimo, Giovanni B. Andornino – docente di Relazioni Internazionali dell’Asia orientale – ricostruisce la logica che ha portato la dirigenza di Pechino a optare e, finora, mantenere una linea di “neutralità abilitante” rispetto alla guerra in Ucraina.
- La guerra in Ucraina e il fascino delle spiegazioni facili
Anna Caffarena - La campagna d’inverno 2022: la finestra d’opportunità e il tragico errore di calcolo della Russia
Gabriele Natalizia - Le ragioni del fallimento della guerra lampo di Putin
Senior Security Analyst - L’orso affamato: i deficit della logistica militare russa
Stefano Ruzza - Dopo l’Ucraina, quale futuro per le capacità di proiezione militare russa nel mondo?
Jean-Marie Reure - Mala tempora: Pechino e l’invasione russa dell’Ucraina
Giovanni B. Andornino
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- La guerra in Ucraina e il fascino delle spiegazioni facili
-

LA NOTTE BIRMANA: PANDEMIA E TENTAZIONI AUTORITARIE IN MYANMAR
N. 16 (2021)Il 1° febbraio 2021 i generali del Myanmar hanno messo fine all’esperimento di democrazia “disciplinata”, a cui loro stessi avevano dato inizio appena dieci anni prima, realizzando un ossimoro politico: un colpo di stato militare quasi “a norma di legge”. Nonostante la Costituzione del 2008 tuteli le prerogative dei militari, la brusca presa di potere da parte dell’esercito birmano ha colto molti osservatori di sorpresa. Se si prendono in esame solo gli ultimi dieci anni, infatti, gli eventi del 1° febbraio sembrano avere caratteri quasi paradossali. Tuttavia, come osserva Stefano Ruzza – autore del primo articolo di questo numero di Human Security e docente di Scienza Politica e di Peace and Conflict Studies presso l’Università degli Studi di Torino – il golpe appare più intellegibile se valutato in relazione al più ampio progetto che i generali birmani avevano già avviato prima della (parziale) liberalizzazione politica e, soprattutto, se si osserva ciò che i militari hanno fatto o annunciato una volta tornati al governo.
La complessità delle dinamiche politiche in Myanmar, però, non si esaurisce nel ruolo e nelle azioni della giunta militare: come spiega nell’articolo seguente David Brenner – docente di Global Insecurities presso la University of Sussex – a partire dal colpo di stato i movimenti ribelli etnonazionali sono tornati al centro della politica del Myanmar. Prendendo in esame il sostegno delle organizzazioni etniche armate Karen e Kachin alla resistenza popolare anti-golpe, Brenner evidenzia come il loro atteggiamento strategico e le loro decisioni siano influenzate dalle diverse relazioni verticali che intercorrono tra leader e basi sociali. A differenza delle ribellioni Karen e Kachin discusse da Brenner, nello Stato Rakhine l’Arakan Army ha mantenuto una certa ambiguità strategica mentre la società civile locale sembra non si sia esposta molto sul deterioramento della situazione politica nel resto del paese. Tra luglio e agosto, l’Arakan Humanitarian Coordination Team (AHCT) ha condotto una serie di interviste – qui riassunte da Lorraine Charbonnier, Research Fellow di T.wai – per meglio comprendere le reazioni del popolo Rakhine agli eventi recenti. Come si evince dalle parole degli intervistati, le ragioni alla base del relativo silenzio dei Rakhine sono anch’esse complesse e derivano da una lunga storia di discriminazione ed emarginazione e dalle aspirazioni politiche del popolo Rakhine e dell’Arakan Army.
C’è poi una dimensione numinosa e oscura delle vicende politiche del Myanmar, un “brodo di coltura” che Massimo Morello – giornalista professionista e indipendente – delinea nel suo articolo per Human Security rifacendosi all’idea di psicomagia di Alessandro Jodorowsky e descrivendo i modi in cui il fondamentalismo buddista, amplificato dalla pratica delle arti esoteriche, si coniuga con l’etnocrazia birmana e le violente repressioni dei militari. Ma non basta: alla psicomagia birmana di cui parla Morello si aggiungono interessi ben più terreni che spostano il focus di questo numero di Human Security sul commercio e la proliferazione di armi leggere in Myanmar a partire dal ritrovamento di un bossolo calibro 12 marcato “Cheddite” – la ditta italo-francese produttrice di munizioni ed esplosivi con base a Livorno – impiegata dai militari birmani durante una delle numerose proteste che hanno incendiato le strade di Yangon dopo il golpe. I primi a interrogarsi su come ci sia finito quel bossolo in Myanmar sono Alessandro De Pascale ed Emanuele Giordana – entrambi giornalisti e collaboratori de il manifesto – che nel loro articolo ricostruiscono il percorso seguito dalle munizioni dell’azienda livornese per giungere prima nelle mani dei militari birmani e poi nell’ordine del giorno della Farnesina e dei parlamentari italiani. Segue un articolo di Francesco Buscemi – ricercatore presso l’Emerging Research in International Security (ERIS) Research Group della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e Research Fellow di T.wai – che approfondisce le dinamiche di proliferazione e acquisizione di armi da parte dei movimenti ribelli politico-armati nei territori del confine del Myanmar.
Questo numero di Human Security dedicato al Myanmar si chiude con un approfondimento sulla situazione sanitaria nelle zone periferiche del paese. Il primo articolo ad affrontare il tema – redatto a partire dai report settimanali dell’AHCT – si concentra sull’impatto socio-economico delle misure anti-COVID-19 nello Stato Rakhine e sulle sfide che le organizzazioni umanitarie si trovano a dover affrontare per poter operare in un contesto di “crisi nella crisi”. Tra queste, c’è anche la torinese MedAcross, che dal 2016 è impegnata in un progetto medico e umanitario nell’estremo sud del Myanmar e che racconta a Human Security gli sforzi fatti per continuare a rispondere alle necessità sanitarie della popolazione più povera del distretto di Kawthaung.
- Il regime dei sogni: nella mente dei generali birmani
Stefano Ruzza - La politica dei ribelli dopo il colpo di stato: le organizzazioni etniche armate del Myanmar e le loro basi sociali
David Brenner - Governance e politica nello Stato Rakhine
Peace and Development Initiative – Kintha, Arakan Humanitarian Coordination Team, Lorraine Charbonnier - Psicomagia birmana
Massimo Morello - Munizioni italiane in Myanmar
Alessandro De Pascale, Emanuele Giordana - La proliferazione di armi leggere nella resistenza al Tatmadaw in Myanmar
Francesco Buscemi - Crisi nella crisi: l’impatto dei lockdown e le sfide all’assistenza umanitaria nello Stato Rakhine
Peace and Development Initiative – Kintha, Arakan Humanitarian Coordination Team, Lorraine Charbonnier - Tagliata fuori: la critica situazione della sanità birmana dopo il colpo di stato
Vittoria Brucoli, Erika Vitale
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Il regime dei sogni: nella mente dei generali birmani
-

GENERE E SESSO, TRA VIOLENZA E POST-CONFLITTO
N. 15 (2021)La Risoluzione 1325 su donne, pace e sicurezza adottata nel 2000 dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha sicuramente contribuito a mettere in luce il ruolo delle donne nei conflitti contemporanei e il loro contributo fondamentale nei processi di pace. Nonostante siano passati più di vent’anni, però, rimangono importanti zone d’ombra e criticità. Come osserva in apertura di questo numero di Human Security Evelyn Pauls – Impact Manager presso l’LSE Centre for Women, Peace and Security – gran parte del (crescente) interesse di accademici, professionisti e decisori politici per il tema è ancora spesso inquadrato in chiave sessista e tende a ignorare le motivazioni e le esperienze delle combattenti donne, il che troppo spesso porta al ritorno e alla normalizzazione dei ruoli di genere tradizionali lasciando inascoltati i bisogni e le richieste di tutte quelle donne che hanno imbracciato le armi, allontanandosi dagli stereotipi della narrativa dominante.
Continuando la riflessione, Leena Vastapuu – Planning and Reporting Officer presso la Missione EUAM RCA e autrice di uno dei capitoli del nuovo Routledge Handbook of Feminist Peace Research – si interroga sul perché le ex-combattenti donne risultino ancora largamente escluse o quantomeno sotto-rappresentate nei processi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione (DDR). Riassumendo le principali spiegazioni offerte dalla prospettiva femminista, Vastapuu sottolinea come le ragioni di tipo ideologico condannino spesso le ex-combattenti a un limbo di oblio in cui non vengono reputate abbastanza soldati per poter accedere ai processi formali di DDR e, contemporaneamente, non risultano abbastanza civili agli occhi delle organizzazioni e movimenti di donne più conformi all’immagine della “madre amante della pace”.
In linea con le osservazioni di Pauls e Vastapuu, Anna Toniolo – laureata in Scienze Internazionali presso l’Università degli Studi di Torino – guarda alle politiche e pratiche di contrasto all’estremismo violento, concentrandosi sul caso del Kosovo e domandandosi se, e fino a che punto, il piano di de-radicalizzazione messo in atto dal governo kosovaro a partire dal 2019 tenga conto e includa nelle varie fasi della programmazione le diverse esperienze e i molteplici ruoli delle donne che si sono unite, volontariamente o meno, allo Stato Islamico.
L’articolo seguente, a firma di Gioachino Panzieri – Junior Research Fellow del programma di Genere Euro-Mediterraneo presso l’Istituto Europeo del Mediterraneo (IEMed) – pone l’accento sugli schemi di violenza sessuale perpetrata nei contesti di detenzione in Siria per analizzare le cause e gli effetti della militarizzazione del sesso e, al contempo, riflettere su come le relazioni gerarchiche di genere informino le regole della guerra e rispondano a interessi politici che danno loro significato, facendosi strumento del mantenimento del potere attraverso lo sfruttamento, l’abuso e il controllo di corpi subalterni.
E sono proprio lo sfruttamento, l’abuso e il controllo dei corpi che trasformano in “percorsi di violenza” i tentativi delle lavoratrici domestiche etiopi di migliorare le proprie condizioni di vita emigrando in Medio Oriente, come racconta nel suo contributo a Human Security Silvia Cirillo – dottoranda in Global Studies presso l’Università di Urbino Carlo Bo. Spostando il focus in America Latina, l’autrice dell’articolo che segue, Marta Michelini – che attualmente lavora per COOPI dopo aver collaborato a un progetto di reinserimento lavorativo di persone desplazadas e in condizione di vulnerabilità in Colombia – affronta il tema delle discriminazioni e violenze di genere in un contesto, come quello colombiano, in cui la pandemia si è intersecata a una situazione post-conflitto già di per sé caratterizzata da una diffusa insicurezza umana.
Infine, l’ultimo articolo di questo numero di Human Security, scritto da Elisa Armando – studentessa di Antropologia della guerra e della violenza presso lo University College di Londra e contributor presso The Women’s Rights Initiative di Kampala – dà voce alle/ai rappresentanti di dodici organizzazioni nordugandesi che, a partire dalla fine del conflitto nella sub-regione Acholi, si sono impegnate in attività di empowerment economico delle donne affinché all’indipendenza economica segua l’emancipazione individuale e sociale dal sistema patriarcale dominante.
- Peacebuilding e combattenti donne: ripensare il coinvolgimento femminile nel conflitto
Evelyn Pauls - Non abbastanza soldati, non abbastanza civili: la continua sotto-rappresentanza delle donne nei programmi di DDR
Leena Vastapuu - Contrastare l’estremismo violento in Kosovo: politiche e pratiche gender blind o gender sensitive?
Anna Toniolo - Genere, agency e strutture di violenza: prospettive femministe sulla militarizzazione del sesso in Siria
Gioachino Panzieri - Percorsi di violenza: il caso delle lavoratrici domestiche etiopi in Medio Oriente
Silvia Cirillo - Uno sguardo alla Colombia: discriminazioni e violenze di genere in tempo di pandemia
Marta Michelini - Tra le donne Acholi, tutto ha inizio da una collana
Elisa Armando
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Peacebuilding e combattenti donne: ripensare il coinvolgimento femminile nel conflitto
-

LA DEMOCRAZIA TRA IL VOTO E LA PIAZZA
N. 14 (2020)Indubbiamente il 2020 verrà ricordato come l’anno della pandemia globale, dei confinamenti e dello “stato di eccezione”. L’anno che sta per concludersi, però, è stato caratterizzato anche da importanti eventi politici, in primis le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America. Ed è proprio dagli Stati Uniti che parte questo numero di Human Security. Se la vittoria di Joe Biden sembra far intravedere la “fine dell’era Trump” e, intuitivamente, nuova linfa per la promozione dell’ordine liberale a livello globale, nel suo articolo Gabriele Natalizia – docente di Scienza Politica e ricercatore presso la Sapienza Università di Roma – traccia la storia della risposta statunitense al “dilemma della democrazia” dalla Guerra fredda a oggi, delineando una soluzione di continuità tutt’altro che scontata nell’approccio strategico delle Amministrazioni Obama, Trump e, con tutta probabilità, Biden.
Sempre nel 2020, la (bio)securitizzazione delle relazioni tra stato e società che ha caratterizzato molti paesi nel mondo è stata accompagnata dall’emergere o dal perdurare di diversi movimenti di protesta. In Bielorussia, le elezioni presidenziali hanno confermato “l’ultimo dittatore d’Europa” alla guida di un paese lacerato dalla situazione economica, sanitaria e sociale. Le elezioni hanno però anche portato nelle piazze bielorusse migliaia di persone a supporto della leadership tutta al femminile dell’opposizione politica, dando una spinta dal basso al processo di democratizzazione. Ce lo racconta Mara Morini – esperta di politica russa e docente di Scienza Politica all’Università di Genova – che, oltre a ripercorrere gli eventi degli ultimi cinque mesi, descrive puntualmente le reazioni di Unione Europea e Russia alla “crisi Lukashenko”.
Anche le piazze di Hong Kong hanno continuato a essere teatro di manifestazioni e scontri. Il 1° luglio 2020 è entrata in vigore la nuova legge sulla sicurezza nazionale che, nei fatti, delegittima e criminalizza il movimento di protesta nato nella primavera del 2019. Come spiega Gaia Perini – sinologa e docente all’Università di Bologna – il pugno di ferro di Pechino ha per ora messo un freno all’attivismo politico e sindacale di Hong Kong, ma, col tempo, questo non può che acuire le ragioni della contestazione e del dissenso, riportando alla memoria l’adagio socialista “dove c’è oppressione, lì scatta la rivolta”. Rimanendo in Asia, l’articolo che segue, firmato da Devparna Roy – docente di Sociologia e Antropologia al Nazareth College di Rochester – sposta il focus di Human Security sulla più grande democrazia al mondo, l’India, descrivendone luci ed ombre a partire dal delicato rapporto tra religione, nazione e tolleranza politica in un paese dal patrimonio culturale estremamente ricco e variegato.
Gli ultimi due articoli di questo numero di Human Security su elezioni e democrazia guardano invece al continente africano e, in particolare, alla Costa d’Avorio e all’Etiopia. Partendo dalla rielezione del Presidente ivoriano Ouattara (in carica dal 2010), Andrea Cassani – docente di Scienze Politiche e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano – affronta il tema del consolidamento delle istituzioni democratiche, analizzando la questione del rispetto e della manipolazione dei limiti di mandato presidenziale in Africa sub-sahariana. Con altrettanto rigore, Anna Myriam Roccatello e Ilaria Martorelli – rispettivamente Deputy Executive Director e Program Expert dell’International Center for Transitional Justice (ICTJ) – offrono un’analisi del difficile processo di riconciliazione e transizione democratica in Etiopia, interrotto dagli scontri politici e armati scatenati dalla gestione unilaterale delle elezioni nazionali (rimandate) e nella regione del Tigrai (tenutesi nonostante il divieto di Addis Abeba).
- Dove osano le aquile. Ascesa e declino della promozione americana della democrazia nel post-Guerra fredda
Gabriele Natalizia - Il regime di Lukashenko tra incognite e repressione politica
Mara Morini - La nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong: il diritto che schiaccia la politica
Gaia Perini - Costruire la nazione, costruire la democrazia: il ruolo della tolleranza politica in India
Devparna Roy - Le elezioni presidenziali 2020 in Costa d’Avorio e la questione dei limiti di mandato in Africa
Andrea Cassani - Etiopia: una transizione interrotta
Anna Myriam Roccatello, Ilaria Martorelli
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Dove osano le aquile. Ascesa e declino della promozione americana della democrazia nel post-Guerra fredda
-

SALUTE E SICUREZZA UMANA
N. 13 (2020)Il 23 marzo 2020, mentre il virus COVID-19 si diffondeva in tutto il mondo e il lockdown teneva in casa gli Italiani, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, chiedeva un immediato cessate il fuoco globale. Al pari del sentimento di solidarietà e comunità, che entrava nelle nostre case dai balconi e che ci faceva pensare, ingenuamente, a un mondo post-pandemia migliore di quello che ci eravamo lasciati alle spalle, il Segretario Generale auspicava che, se accolto, il suo appello potesse permettere alla comunità internazionale di concentrarsi sulle sfide poste dalla pandemia e, perché no, fornire un’opportunità per mettere fine ai conflitti in corso in modo diplomatico. Il primo articolo di questo numero di Human Security, però, spiega come ciò non solo non sia accaduto, ma come in alcuni contesti con il cessate il fuoco si sia assistito a un aumento della violenza e a un peggioramento delle dinamiche del conflitto. Come sottolinea Kieran Mitton, docente di Relazioni Internazionali presso il King’s College London e co-fondatore dell’Urban Violence Research Network, infatti, la natura temporanea dei cessate il fuoco “da COVID-19” e le difficoltà riscontrate nel dominare la violenza nel mondo, confermano alcuni aspetti chiave emersi in decenni di ricerca sui conflitti armati e mettono in luce alcune delle criticità principali dei processi di negoziazione e costruzione della pace.
Se le immagini di guerre e povertà che ci vengono raccontate dai media ci portano il più delle volte a guardare ai cosiddetti “stati falliti” del Sud del mondo, l’attuale pandemia ha forzatamente riorientato il nostro sguardo, svelando le debolezze del sistema internazionale nel suo complesso, ma anche e soprattutto di quegli “stati forti” che, in tempi “normali”, vantano una posizione di leadership economica, militare e culturale. Partendo dal caso degli Stati Uniti e in particolare dal rapporto tra il Governo federale e le nazioni degli Indiani d’America, l’articolo di Charles Geisler, Professore Emerito di Sociologia dello Sviluppo presso la Cornell University, accompagna i lettori in una riflessione sul significato di fallimento statale e sul nesso tra sicurezza nazionale e salute pubblica. Anche Francesca Fortarezza, dottoranda presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e autrice dell’articolo successivo, si interroga questo rapporto e lo fa concentrandosi sugli “effetti collaterali” delle misure “straordinarie” che i governi di tutto il mondo hanno messo in atto per far fronte a una minaccia “eccezionale” e sul ruolo dei difensori dei diritti umani come anticorpi contro la crisi sociale che stiamo attraversando.
Leggendo le parole di Geisler e Fortarezza diventa chiaro come, nei fatti, una pandemia sia molto di più di un problema puramente sanitario e, di conseguenza, richieda un’azione articolata da parte di una moltitudine di attori. In un’ottica simile, l’approccio One Health, promosso dall’iniziativa Global Health Security Agenda, riconosce l’interconnessione tra esseri umani, animali e ambiente e promuove un approccio collaborativo, multi-settoriale e transdisciplinare, per raggiungere uno stato di salute ottimale e sistemico per il pianeta. Ce lo raccontano Micol Fascendini, Daniela Rana, Elena Cristofori ed Elena Comino che, nel loro articolo per Human Security, condividono con i lettori l’esperienza del Comitato Collaborazione Medica (CCM) in Kenya, nella contea di Marsabit, dove il CCM è impegnato a promuovere la salute e la resilienza delle comunità pastorali. Come si evince dai risultati della ricerca interdisciplinare condotta dal team del CCM, per prevenire e gestire infezioni ed epidemie è necessario comprendere non solo gli aspetti medici della salute umana, ma anche quelli socio-culturali della salute umana. Di opinione simile è Jerome Ntege, dottorando presso la Makerere University, che nel suo articolo riprende e approfondisce da un’ottica antropologica le riflessioni sul rapporto tra sicurezza nazionale e sicurezza umana raccontando l’esperienza e le percezioni degli abitanti del distretto di Bundibugyo, al confine tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, nell’affrontare l’epidemia di Ebola del 2007.
Il tredicesimo numero di Human Security si chiude con la testimonianza di chi, da anni e ben prima dello scoppio della pandemia di COVID-19, si occupa di salute ed emergenze sanitarie in contesti di conflitto e insicurezza diffusa: se Giovanna De Meneghi ed Edoardo Occa di Medici con l’Africa CUAMM evidenziano come il lavoro degli operatori sanitari si inserisca in un contesto relazionale e sociale che non può essere ignorato, Anna Maria Abbona Coverlizza ed Erika Vitale di MedAcross forniscono un esempio concreto di come la cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario richieda una flessibilità e una capacità di adattamento notevoli, soprattutto quando la realtà operativa diventa quella di una pandemia globale.
- Costruire la pace in pandemia: Prospettive e trappole
Kieran Mitton - La sfida del COVID: Salute e sicurezza nazionale negli stati falliti
Charles Geisler - Anticorpi contro la crisi: diritti umani, salute e sicurezza in tempo di pandemia
Francesca Fortarezza - One Health, approccio multidisciplinare per promuovere la sicurezza sanitaria globale
Micol Fascendini, Daniela Rana, Elena Cristofori, Elena Comino - Ebola nelle frontiere: Una nuova dimensione di insicurezza umana
Jerome Ntege - Scenari possibili e strategie per garantire servizi minimi essenziali nel conflitto a bassa intensità nella provincia di Cabo Delgado, Mozambico. L’esperienza in corso di Medici con l’Africa CUAMM
Giovanna De Meneghi, Edoardo Occa - MedAcross – Il diritto alle cure per tutti
Anna Maria Abbona Coverlizza, Erika Vitale
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Costruire la pace in pandemia: Prospettive e trappole
-

UN PRIMO RITRATTO DEL PEACEBUILDING ITALIANO
N. 12 (2020)In Italia le riflessioni più immediatamente disponibili al pubblico in materia di pace, sicurezza e conflitto si limitano a sporadiche notizie di geopolitica o – peggio – si declinano in sterile propaganda politica, peraltro con riferimenti scarsi o nulli al tema del peacebuilding. Nel contesto nazionale, quest’ultimo sembra trovare un suo spazio solo nei discorsi “introspettivi” di accademici, specialisti e tecnici, rimanendo ai margini del discorso pubblico e del dibattito politico. Eppure, tanto la Costituzione italiana quanto la legislazione attualmente in vigore sulla cooperazione allo sviluppo riconoscono la promozione della pace e la prevenzione dei conflitti come obiettivi fondamentali e parte qualificante della politica estera italiana. Oltre al suo tradizionale impegno multilaterale, poi, l’Italia mantiene una solida presenza sul campo e ha un’esperienza consolidata in paesi fragili e in crisi attraverso le attività di una moltitudine di attori, governativi e non. Nei fatti, dunque, sembra esistere un “peacebuilding italiano”, seppur poco compreso e ancor meno valorizzato.
A fronte di queste considerazioni, questo numero di Human Security si propone di delineare i contorni degli sforzi italiani a sostegno della pace a partire dalla prospettiva di attori e mondi diversi, da quello dei think tank a quello istituzionale e diplomatico passando per quello delle organizzazioni non governative.
Il 2020 necessariamente richiederà all’Italia, così come a tutti i paesi colpiti dal COVID-19, un ripensamento generale delle priorità e lo sviluppo di una visione per il mondo post-pandemia. Se è vero che molto potrebbe cambiare nel prossimo futuro, è anche tristemente certo che i conflitti e l’insicurezza che oggi affliggono molte società non spariranno. La speranza è, quindi, che le riflessioni contenute in questo numero di Human Security possano offrire spunti utili per iniziare un ragionamento più ampio, inclusivo e sistematico sul peacebuilding “made in Italy”.
- Osservare il peacebuilding italiano con gli occhi dei suoi protagonisti
Lorraine Charbonnier, Stefano Ruzza - Sostenere il peacebuilding in un’Europa che cambia
Pauline Veron, Andrew Sherriff - Il peacebuilding italiano: opportunità, ostacoli e prospettive
Luisa Del Turco - Un nuovo peacebuilding italiano? Corpi Civili di Pace e post-conflitto in Colombia
Riccardo Toso - Una penna spuntata
Emanuele Russo - Peacebuilding: nascita e sviluppo in ambito onusiano. Il punto di vista di Mariangela Zappia, Rappresentante Permanente italiana presso le Nazioni Unite a New York
Mariangela Zappia - Il contributo italiano agli sforzi dell’OSCE nel sostenere la pace. Intervista a Mario Alberto Bartoli, Capo VI Ufficio (OSCE) della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza presso il MAECI
Stefano Ruzza - Il peacebuilding italiano tra idee, pratica e percezioni. Riflessioni a partire da una conversazione con Francesco Talò, Rappresentante Permanente italiano presso la NATO a Bruxelles
Lorraine Charbonnier - Il futuro del peacebuilding e il ruolo dell’Italia
Valentina Bartolucci, Bernardo Venturi - Il peacebuilding italiano: un primo ritratto e due possibili sviluppi
Stefano Ruzza, Lorraine Charbonnier
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Osservare il peacebuilding italiano con gli occhi dei suoi protagonisti
-
ARMI E SICUREZZA: QUALI RIFORME?
N. 11 (2020)Il volume dei trasferimenti internazionali di armi è aumentato rispetto al passato, raggiungendo nel 2018 il livello più alto dalla fine della Guerra fredda e un valore commerciale di circa 95 miliardi di dollari nel 2017. Naturalmente esistono una serie di regole, concordate a livello regionale e internazionale, per il commercio di armi. Tuttavia, le ambiguità non mancano e la recente escalation del conflitto in Yemen ha messo in luce profonde differenze nel modo in cui gli stati membri dell’Unione Europea interpretano e mettono in atto tali norme: mentre alcuni stati hanno interrotto o limitato le esportazioni di materiale militare verso l’Arabia Saudita, altri le hanno portate avanti. Inoltre, come racconta Giovanna Maletta, ricercatrice del SIPRI, in alcuni casi – come nel Regno Unito e in Italia – la legalità di queste esportazioni è stata messa in dubbio a fronte di preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani e dei principi cardine del diritto internazionale umanitario.
Partendo da simili considerazioni, nel 1997 la comunità internazionale si è impegnata a mettere al bando le mine anti-persona e rimuovere gli ordigni disseminati nel mondo. Nonostante ciò, si stima che ve ne siano ancora decine di milioni sparse in tutto il mondo. La bonifica dei campi minati va dunque avanti e molte sono le organizzazioni impegnate in missioni di questo tipo. Fra queste, APOPO figura da molti anni tra i principali attori impegnati sul campo, affidandosi a una “tecnologia” innovativa, estremamente accurata ed efficiente: l’olfatto dei ratti giganti africani. Per scoprirne di più, Francesco Merlo, Project Assistant presso CVM – Comunità Volontari per il Mondo, ha intervistato Abdullah Mchomvu, responsabile dell’addestramento degli HeroRAT di APOPO.
Dopo il focus sulle sfide legali del commercio internazionale di armi e le attività di bonifica di APOPO, questo numero di Human Security si concentra sulla riforma del settore della sicurezza o, in gergo, Security Sector Reform (SSR). Ne parla il Tenente Colonnello Paolo Mazzuferi, Capo Sezione Studi e Dottrina del Centro Studi Post-Conflict Operations dell’Esercito Italiano, che nel suo articolo traccia l’evoluzione e delinea i contorni dei modelli contemporanei di SSR. Segue un articolo di Giuseppe Lettieri, oggi Monitoring Officer presso la Missione OSCE a Skopje, che offre una riflessione sull’importanza e le criticità della riforma del sistema penitenziario kosovaro, collocandone il processo a cavallo tra SSR e riforma dell’ordinamento giudiziario.
Affini e per certi versi complementari alle attività di SSR sono i programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione degli ex combattenti (Disarmament, Demobilisation and Reintegration, DDR), oggetto dell’ultimo approfondimento di questo undicesimo numero di Human Security. Come sottolineato da Irene Baraldi, Blue Book Trainee presso la Commissione Europea, e Alpaslan Özerdem, Dean della School for Conflict Analysis and Resolution della George Mason University, i programmi di DDR sono uno degli aspetti più delicati e impegnativi dei processi di costruzione della pace, soprattutto considerando le loro possibili conseguenze sui rapporti di potere nelle società post-conflitto (come analizzato da Baraldi in merito al caso bosniaco) e delle loro ripercussioni sulla sicurezza umana di diversi gruppi e sub-gruppi di ex combattenti (come osservato da Özerdem).
- Le sfide legali alle esportazioni di armi dall’UE verso l’Arabia Saudita: situazione attuale e potenziali implicazioni
Giovanna Maletta - Addestrare ratti per salvare vite: la missione di APOPO raccontata da Abdullah Mchomvu, Mine Detection Rats Training Manager
Francesco Merlo - Security Sector Reform: evoluzione e consolidamento del concetto nel panorama internazionale
Paolo Mazzuferi - La riforma del sistema penitenziario a cavallo tra SSR e riforma degli ordinamenti giudiziari: il caso kosovaro
Giuseppe Lettieri - DDR in Bosnia ed Erzegovina: un caso d’eccezione
Irene Baraldi - One Size Doesn’t Fit All: i programmi di DDR e l’eterogeneità degli ex combattenti
Alpaslan Özerdem
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Le sfide legali alle esportazioni di armi dall’UE verso l’Arabia Saudita: situazione attuale e potenziali implicazioni
-

GOVERNANCE E ISTITUZIONI AL DI LÀ DELLO STATO
N. 10 (2019)Con l’approvazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nel 2015, la comunità internazionale ha cercato di superare l’idea che lo sviluppo sostenibile sia unicamente una questione ambientale ed economica affermando invece una visione integrata dello sviluppo che ne valorizzi anche e soprattutto la dimensione umana e sociale. Non solo, con l’Agenda 2030 la comunità internazionale ha anche cristallizzato l’idea che sviluppo e pace siano due facce della stessa medaglia, raggiungibili solamente in tandem grazie a buona governance e istituzioni forti che siano trasparenti, efficaci e responsabili (Sustainable Development Goal 16, SDG 16 nell’acronimo inglese).
Nonostante l’Agenda 2030 parta dal presupposto che per essere “buona” la governance deve essere inclusiva e rappresentativa di tutte le frange della società, questo piano d’azione per lo sviluppo globale si concentra principalmente sui sistemi di governo formali, riflettendo una più ampia tendenza della comunità internazionale a concepire società, stati e governance in modo meccanicistico e tecnocratico. Nel tentativo di offrire ai lettori una riflessione più ampia, questo numero di Human Security è dedicato alle forme alternative di governance che emergono in situazioni di conflitto, debolezza statale e scarsa sicurezza umana.
Come sottolinea anche Mats Berdal, direttore del Conflict, Development and Security Research Group del King’s College London, l’obiettivo non è però quello di romanticizzare sistemi e istituzioni informali, ma di decostruire l’idea di stato weberiano e sfumare le distinzioni binarie tra stato e non-stato, legittimo e non-legittimo, governance e non-governance per meglio comprendere l’impatto – complesso e trasformativo – che guerre e conflitti violenti hanno sulla società e le realtà politiche ed economiche che vengono create di conseguenza.
Sempre guardando al ruolo dello stato nell’attuale contesto globale, Fabio Armao, docente di Urban Security e di Politica e Processi di Globalizzazione all’Università di Torino, si interroga su come la proliferazione di forme ibride giuridiche al di là dello stato stia cambiando l’economia del potere nella società globalizzata, portando anche all’emergere di attori in grado di sfidare direttamente il potere statale: i responsabili dei cosiddetti white-collar crime e i mafiosi.
Fra i cardini dell’Agenda 2030, in generale, e dell’SDG 16, nello specifico, vi sono anche la lotta alla corruzione e l’equo accesso alla giustizia. Benché spesso trattati come due fenomeni distinti, nel suo articolo Edgardo Buscaglia, Senior Research Scholar alla Columbia University, spiega attraverso un’analisi giurimetrica come i crescenti livelli di corruzione siano sempre associati a una maggiore presenza di reti di criminalità organizzata e che più questi attori riescono a integrarsi nel settore economico meno lo stato è in grado di garantire l’accesso alla giustizia formale, spingendo quindi la popolazione ad affidarsi a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.
Partendo invece da una ricerca etnografica, David Brenner, docente di International Relations presso Goldsmiths, University of London, dimostra come in alcuni contesti – come quello del Myanmar – sia proprio lo stato a rappresentare una delle principali fonti di insicurezza per gran parte della popolazione e che, quindi, la promozione di società pacifiche, giuste e inclusive debba necessariamente tenere in considerazione la dimensione etno-politica del conflitto per poter coinvolgere quelle istituzioni che si collocano al di là dello stato formalmente inteso e che contribuiscono direttamente ad aumentare la sicurezza umana delle comunità locali.
Sulla stessa linea e in chiusura di questo numero di Human Security, Francesca Fortarezza, laureata in Scienze Internazionali all’Università di Torino, riflette su come contestualizzandolo in realtà “ibride” come quella messicana, l’SDG 16 sia esposto a due incomprensioni fondamentali: quella dell’oggetto – cioè della situazione da trasformare – e quella del risultato da ottenere – cioè della condizione di pace, giustizia e sicurezza da raggiungere.
- Il mito dello “spazio non governato” – alcune implicazioni per lo state-building e la sicurezza umana
Mats Berdal - Il paradosso della legalità: l’iper-normativismo come fattore di erosione del potere dello stato
Fabio Armao - Contrastare la criminalità organizzata a partire dalla riforma della giustizia
Edgardo Buscaglia - Pace, giustizia e istituzioni forti al di là dello stato: il Salween Peace Park in Myanmar
David Brenner - Creare spazi di pace e di sviluppo sostenibile: l’accompagnamento protettivo internazionale come metodo non-violento di trasformazione dei conflitti
Francesca Fortarezza
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Il mito dello “spazio non governato” – alcune implicazioni per lo state-building e la sicurezza umana
-

IL GENOCIDIO FRA MEMORIA, DIRITTO E MANIPOLAZIONE POLITICA
N. 9 (2019)Nonostante l’adozione di un’apposita Convenzione da parte delle Nazioni Unite nel 1948, l’impiego del termine ‘genocidio’ continua a generare confusione e ambiguità – non solo in ambito legale – come sottolineato da Marzia Ponso, ricercatrice e docente di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino. Se la Convenzione riporta infatti una definizione ristretta, che esclude le vittime appartenenti a minoranze politiche, i tribunali penali internazionali degli anni novanta hanno fornito una ridefinizione più ampia del fenomeno. Se la distinzione rispetto al ‘democidio’ appare netta, il riconoscimento di molte tragedie storiche come genocidio risulta ancora foriero di scontri e divisioni profonde.
È ancora oggetto di controversie, ad esempio, il caso bosniaco, raccontato in questo numero di Human Security da Arianna Piacentini, ricercatrice post-doc presso l’EURAC Research di Bolzano. Le guerre jugoslave dei primi anni novanta diedero sfogo alla strumentalizzazione politica delle differenze identitarie mentre le mire delle nuove potenze regionali portarono all’uso della pulizia etnica in Bosnia ed Erzegovina come strumento di conquista e consolidamento territoriale. L’eccidio di Srebrenica del 1995 rappresenta l’apice di un processo di cancellazione identitaria lungo almeno un decennio, ma parlare di genocidio rimane terreno di scontro acceso mentre le tensioni nazionalistiche continuano ad alimentare la narrazione politica regionale.
È invece generalmente riconosciuto il carattere genocidario del Metz Yeghern, lo sterminio degli Armeni nel 1915, anche se – come sottolinea il giornalista freelance Simone Zoppellaro – esso rappresenta un caso emblematico e per molti versi estremo di politicizzazione di un fatto storico. Già Raphael Lemkin aveva preso a riferimento le similitudini tra Shoah e Metz Yeghern per coniare il neologismo ‘genocidio’, eppure, il riconoscimento di questa tragedia come tale rimane al centro di crisi diplomatiche, tensioni politiche e silenzi – in Turchia e non solo.
Tristemente famoso è anche il caso del Ruanda che, insieme alla Shoah è stato spesso elevato a paradigma delle dinamiche genocidarie. A venticinque anni dal genocidio, Caterina Clerici ed Eléonore Hamelin, rispettivamente giornalista e video-giornalista freelance, raccontano la realtà delle donne ruandesi, tra i traumi del passato e il boom economico di oggi. Laddove le atrocità del 1994 avevano lasciato in eredità oltre 800mila morti, la quasi totale estraneità delle donne nella perpetrazione dei massacri ha permesso di elevarle a protagoniste del processo di ricostruzione nazionale. Mentre il Tribunale penale internazionale del Ruanda ha riconosciuto per la prima volta lo stupro come arma genocidaria, le migliaia di vittime e i bambini nati a seguito di quelle violenze restano però il simbolo di ferite profonde che, ancora oggi, la società civile fatica a ricucire.
Spinosa anche la questione della memoria storico-giuridica dei massacri del 1965 in Indonesia e della persecuzione degli Ebrei in Italia durante la Seconda guerra mondiale. Nel suo articolo, Guido Creta, laureato in Storia indonesiana presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, descrive come lo sterminio di mezzo milione di Indonesiani per mano del regime di Suharto rimanga tuttora avvolto in un cupo silenzio, seppellito da definizioni legali, considerazioni geopolitiche e negazionismo sistematico – con evidenti conseguenze sul contesto indonesiano attuale. Come sottolinea Creta, infatti, se è vero che definizioni legalistiche e processi di riconciliazione possono essere ottimi strumenti, non sono sufficienti per superare una tragedia simile se non accompagnati da una ricostruzione storica rigorosa e dall’individuazione dei responsabili. Di simile avviso è Nicolò Bussolati, avvocato e dottorando in Diritto penale internazionale, che nel suo articolo ripercorre la storia della persecuzione razziale in Italia per evidenziare come la mancanza di sanzioni o quanto meno di un momento di valutazione pubblica dei crimini commessi durante il periodo fascista lasci una profonda e pericolosa lacuna nella memoria storica italiana.
Per quanto gli orrori commessi in passato abbiano creato, almeno in linea di principio, uno stigma storico, non mancano oggi i casi di persecuzione su base identitaria, talvolta etichettati come ‘genocidi’ dalla società civile e dai media. Fra questi, ancora in evoluzione risulta la vicenda dei Rohingya, in Myanmar: le brutali campagne di terra bruciata condotte dal Tatmadaw a partire dal 2017 hanno causato la morte di migliaia di civili, lo stupro di centinaia di donne e l’arresto di diverse centinaia di persone. Come racconta Kyaw Zeyar Win, ricercatore presso il Peace Research Institute di Yangon, però, la “crisi dei Rohingya” non è un fenomeno nuovo ma il tragico risultato di politiche e pratiche istituzionalizzate di esclusione e discriminazione che non dovrebbero venire oscurate da dalla drammatica situazione umanitaria dei campi rifugiati in Bangladesh.
- Il problema della definizione di genocidio
Marzia Ponso - Memoria e oblio. Pulizia etnica e genocidio in Bosnia ed Erzegovina.
Arianna Piacentini - Un secolo per rompere il silenzio: il genocidio armeno fra storia e negazionismo
Simone Zoppellaro - Il futuro del Ruanda è delle donne
Caterina Clerici, Eleonore Hamelin - Un silenzio lungo cinquant’anni: le violenze del 1965 in Indonesia
Guido Creta - L’Italia e la razza: memorie storico-giuridiche di un passato dimenticato
Nicolò Bussolati - La crisi dei Rohingya: fra emergenza umanitaria e insicurezza umana
Kyaw Zeyar Win
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Il problema della definizione di genocidio
-

AL DI LÀ DEL MURO: TRA VECCHI EQUILIBRI E NUOVE DINAMICHE
N. 8 (2018)I recenti avvenimenti del Mar d’Azov e il rapido approssimarsi delle elezioni ucraine hanno nuovamente portato sotto gli occhi del mondo non solo la regione del Donbass, ma tutta l’area un tempo sottoposta all’influenza sovietica. Se nel solo conflitto ucraino si contano oltre diecimila morti dal 2014 a oggi, le tensioni tra le diverse identità politiche rimangono altissime e le dinamiche geopolitiche quantomeno rischiose.
L’ottavo numero di Human Security volge così lo sguardo a est, concentrandosi su una delle aree di conflitto più discusse e tormentate degli ultimi decenni. Dalla penisola balcanica alle cime caucasiche, la dimensione della sicurezza pone interrogativi cronici ed eterogenei, che dalla scena internazionale si estendono a quella locale, diventando fonte di preoccupazione quotidiana.
Oggi come trent’anni fa, la chiave di volta della regione risiede a Mosca. Se il crollo dell’Unione Sovietica aveva lasciato un improvviso vuoto di potere, dall’altra parte della “cortina di ferro” le risorse politiche e strategiche per imprimere un’accelerazione decisa al processo di democratizzazione dell’ex blocco sovietico sono state – e sembrano essere tutt’ora – insufficienti. In questo quadro, Irina Busygina, docente presso la Higher School of Economics di San Pietroburgo, evidenzia il fallimento della strategia temporeggiatrice dell’Unione Europea: le grandi speranze democratiche degli anni Novanta si sono oggi scontrate con la realpolitik e i modi autoritari del Cremlino, sempre meno disposto a tollerare intrusioni in quelle che considera aree di esclusiva influenza russa.
Al contempo, le relazioni politiche appaiono fortemente compromesse dalla paralisi nel processo di pace in Ucraina; il conflitto iniziato nel 2014, infatti, ha trovato nel febbraio 2015 un equilibrio tutt’altro che stabile. Analizzando i tre pilastri degli accordi di Minsk, Giulio Benedetti, studente presso la Higher School of Economics di San Pietroburgo, sottolinea lo stallo nel rispetto dei termini di pace, con i separatisti reticenti a sottomettersi nuovamente al controllo di Kiev che, dal canto suo, non sembra intenzionata a garantire quegli ampi margini di autonomia costituzionale che erano stati invece determinanti per il raggiungimento del cessate il fuoco. Il malcontento della popolazione e le difficoltà economiche, d’altra parte, creano un clima politico che, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali, appare pericoloso.
Il disegno strategico di Mosca, al contrario, risulta saldo e coerente. Negli ultimi vent’anni Putin ha coagulato un ampio consenso intorno al suo disegno di restaurazione della Russia quale potenza protagonista dello scenario internazionale. Gabriele Natalizia, docente e ricercatore presso la Link Campus University, evidenzia come il presidente russo abbia instradato la propria linea politica su due binari che corrono in direzione opposta all’approccio multilivello e consensuale dell’Unione Europea: l’accentramento autoritario in reazione alle spinte autonomiste e il ripristino di una zona d’influenza politica esclusiva. Se i metodi di Mosca hanno suscitato forti impressioni nell’opinione occidentale, a Stati Uniti e Unione Europea è mancata però la determinazione politica a supportare alleati geograficamente remoti, come evidenziato dal conflitto georgiano del 2008.
Proprio il Caucaso appare come uno dei contesti dove le tensioni regionali risultano maggiormente esplosive. In un territorio punteggiato dalle rivendicazioni identitarie – nota Marco Valigi, docente e ricercatore presso l’Università degli studi di Bologna – la svolta verso un maggior interventismo della nuova amministrazione Trump rischia di sconvolgere i fragili equilibri attuali, rendendo nuovamente possibili i conflitti per procura, o proxy war.
Il carattere identitario del conflitto, d’altronde, resta pericolosamente vivo anche nei Balcani e soprattutto in Kosovo dove, a quasi vent’anni dalla fine della guerra, il processo distensivo tra la popolazione serba e quella kosovara resta difficile. Prendendo in considerazione l’enclave serba di Velika Hoča, Francesco Trupia, dottorando presso la Sofia University St Kliment Ohridski e collaboratore per il Forum for Glocal Change, sottolinea come la dimensione locale e la sfera del quotidiano, spesso trascurate dalle analisi top-down, rappresentino nuove sfide e opportunità per comprendere le relazioni tra Serbia e Kosovo.
Proprio la popolazione locale ritrova centralità nel quadro della missione OSCE in Kosovo (OMiK). William Brame, Lead Advisor presso EUAM, e Giuseppe Lettieri, membro del Department of Security and Public Safety dell’OSCE al momento della stesura dell’articolo, concludono questo numero di Human Security evidenziando i risultati del processo di riforma del settore della sicurezza (Security Sector Reform, SSR) nell’area di Ferizaj-Uroševac. Ponendo al centro della formazione delle forze di polizia il rapporto con le vittime di violenza, il progetto pilota “Confidence and Satisfaction in the Kosovo Police” ha aumentato la fiducia dei cittadini rispetto alle forze di polizia e, di conseguenza, contribuito a una rinnovata legittimità delle istituzioni locali, determinante per la riuscita dell’intera missione di pace e per la stabilità del paese.
- UE-Russia: quale futuro?
Irina Busygina - Economia e identità nel Donbass
Giulio Benedetti - Arrestare la democrazia? La sfida russa alla leadership americana nel Caucaso meridionale
Gabriele Natalizia - Competizione geopolitica o proxy war? Il Caucaso meridionale e le politiche di sicurezza di Russia e Stati Uniti
Marco Valigi - Identità, esclusione e disaffezione politica: l’enclave serba di Velika Hoča
Francesco Trupia - Aumentare la fiducia e la soddisfazione dell’opinione pubblica nelle attività di polizia attraverso un victim-centred approach: un progetto pilota in Kosovo
Giuseppe Lettieri, William Brame
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- UE-Russia: quale futuro?
-

CONFLITTO, SICUREZZA UMANA E NUOVE TECNOLOGIE
N. 7 (2018)Nel 2010, gli utenti di internet erano meno di 2 miliardi. Oggi, circa metà della popolazione mondiale è online e la crescita è rapida, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. I nuovi prodotti e servizi di cui disponiamo stanno però facendo molto di più che fornire nuove possibilità: stanno cambiando il nostro modo di vivere, lavorare e relazionarci gli uni con gli altri.
Dai robot alle auto a guida autonoma, quella che fino a qualche anno fa sembrava solo fantascienza è oggi diventata realtà. Se è vero che l’intelligenza artificiale potrebbe migliorare notevolmente le nostre vite, è anche vero, però, che tutte le tecnologie possono essere utilizzate sia per contribuire al progresso umano che per servire obiettivi meno nobili, se non addirittura criminali. Il settimo numero di Human Security è quindi dedicato ad alcuni degli aspetti più critici della cosiddetta Quarta rivoluzione industriale e, in particolare, alla trasformazione tecnologica del conflitto e della sicurezza.
Ciò che vale per la sfera privata o per il settore industriale, infatti, vale anche per la guerra. Come sempre più spesso si legge sui giornali, i conflitti contemporanei non si limitano più ai tradizionali campi di battaglia – suolo, mare e aria – ma sembrano aver varcato la soglia di una nuova arena, potenzialmente sconfinata: lo spazio cibernetico. Non sorprende, quindi, il crescente interesse e la sempre maggiore attenzione alla cybersecurity. Giampiero Giacomello, docente di scienza politica all’Università di Bologna, sottolinea quanto l’uso di nuove tecnologie in settori sensibili come la finanza, l’assistenza sanitaria, le telecomunicazioni e i trasporti porti con sé nuovi rischi ed esponga governi e cittadini a “guerre con il computer” che possono colpire chiunque, dovunque e in qualsiasi momento.
Tra le tante sfide che il mondo deve affrontare, quella forse più intensa è capire quale sarà l’evoluzione del rapporto uomo-macchina in ambito bellico: è possibile delegare ai robot l’attività che da sempre ci distingue da tutti gli altri esseri viventi? Nel suo articolo, Christopher Coker, docente di relazioni internazionali alla London School of Economics and Political Science, approfondisce il tema, basando il proprio ragionamento sulle differenze fondamentali fra intelligenza artificiale e intelligenza umana.
Al di là delle possibili traiettorie future, l’impiego di armi in grado di agire autonomamente dall’intervento umano è realtà in diversi contesti di conflitto già da molti anni. Nonostante ciò, l’unico tentativo concreto di regolamentarne l’uso rimane quello di Isaac Asimov, che nel 1950 elaborò le tre leggi della robotica. Affrontando il tema da una prospettiva giuridica, Andrea Spagnolo, docente di Diritto internazionale umanitario presso l’Università di Torino, analizza il dibattito scaturito dal lavoro del Gruppo di esperti sulle armi autonome nell’ambito della Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) ed evidenzia come la mancata regolamentazione delle armi autonome possa compromettere il rispetto dei principi cardine del diritto umanitario stabiliti dalle Convenzioni di Ginevra.
Se nel 1949 gli stati hanno riconosciuto la necessità di aderire a regole che proteggano i civili in tempo di guerra, Pier Luigi Dal Pino, direttore centrale delle relazioni istituzionali e industriali di Microsoft Italia e Austria, sottolinea la necessità di una Digital Geneva Convention che protegga i civili nel cyberspazio anche in tempo di pace. Descrivendo il ruolo fondamentale e l’impegno del settore privato nella prevenzione e nella gestione degli attacchi informatici, Dal Pino introduce il Cybersecurity Tech Accord, siglato recentemente dalle principali imprese informatiche, ed incoraggia i governi a fare altrettanto.
Chiude questo numero di Human Security un articolo a firma di Gioachino Panzieri, neolaureato presso l’Università di Torino, che guarda all’uso della tecnologia e in particolare all’attivismo digitale come strumento di analisi capace di catturare la complessità dei conflitti contemporanei a partire “dal basso” e quindi in grado di restituire un ruolo di primo piano alla popolazione locale e alla digital community a cui si l’informazione si rivolge.
- Cybersecurity o Human Security?
Giampiero Giacomello - La guerra e l’avvento dell’intelligenza artificiale
Christopher Coker - La regolamentazione delle armi autonome: letteratura o diritto?
Andrea Spagnolo - Dal Cybersecurity Tech Accord a una Digital Geneva Convention: responsabilità, fiducia e impegno condiviso
Pier Luigi Dal Pino - La comunicazione digitale degli attivisti come lente di analisi del conflitto siriano
Gioachino Panzieri
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Cybersecurity o Human Security?
-

LA FRONTIERA URBANA DELLA SICUREZZA
N. 6 (2018)Più della metà della popolazione mondiale vive oggi in contesti urbani. Entro il 2030 due persone su tre vivranno in centri metropolitani, mentre entro il 2050 questo rapporto salirà a tre persone su quattro. Sotto la spinta di un’urbanizzazione senza precedenti, le città stanno emergendo come crocevia politici, economici e culturali, e ridefinendo le agende internazionali di sviluppo e sicurezza.
Nonostante le molte opportunità offerte dalle città, alcune zone urbane sembrano oggi riecheggiare le criticità associate ai cosiddetti stati fragili o falliti. In queste “città fragili” le autorità statali faticano infatti a fornire servizi di base e ad assicurarsi il monopolio sull’uso legittimo della forza, lasciando spazio a vecchi e nuovi attori non-statali. Nel frattempo la vita quotidiana sembra per molti versi sempre più paragonabile alla vita in zone di guerra.
In altre parole, le città rappresentano nuove arene di complessi conflitti politici, sociali ed economici e, per questa ragione, negli anni a venire saranno al centro di un maggiore impegno da parte di accademici, policy-makers e practitioners. Su questa linea, i testi e le immagini di questo numero di Human Security richiamano l’attenzione sulla dimensione urbana della violenza e della sicurezza umana nel tentativo di evidenziarne le diverse sfaccettature e le criticità che ne derivano, tanto per chi studia questi fenomeni quanto per chi in questi contesti fornisce aiuti umanitari o lavora per ridurre e prevenire la violenza.
Kieran Mitton, autore del primo articolo di questo numero e docente di Relazioni Internazionali al King’s College di Londra, analizza i fattori che contribuiscono alla crescente centralità della violenza urbana nelle dinamiche globali di conflitto, sicurezza e sviluppo. Mitton afferma che con tutta probabilità sarà infatti questo fenomeno a caratterizzare il XXI secolo, richiedendo quindi un maggiore sforzo collettivo da parte degli attori coinvolti nella formulazione di risposte adeguate. Segue un articolo di Tommaso Messina, ricercatore e analista presso la Institutional Shareholder Services, che, partendo dal riconoscimento della maggiore sistematicità con cui diverse organizzazioni internazionali affrontano oggi il tema della violenza urbana, esplora i presupposti su cui si basa questa nuova traiettoria di interventi umanitari e riflette sui limiti derivanti da come la violenza urbana viene rappresentata e compresa dalle organizzazioni umanitarie.
Una delle manifestazioni più note della violenza urbana è sicuramente il fenomeno delle street gang. Nonostante esse non rappresentino una novità in assoluto e siano diffuse in tutto il mondo, gli aspetti identitari, organizzativi e culturali che contraddistinguono le gang sono spesso trascurati. A fronte di questa mancanza, Fabio Armao, docente di Urban Security e di Politica e Processi di Globalizzazione presso l’Università degli Studi di Torino, descrive come le gang siano in grado di accrescere la coesione intragruppo attraverso la creazione di subculture e di ideologie, capaci di fornire ai loro membri un sistema di regole e norme comuni che, a loro volta, contribuiscono ad alimentare un senso di appartenenza e identità collettiva che il contesto istituzionale non riesce a garantire loro. Continua la riflessione sulle gang, Donna De Cesare, ricercatrice, fotografa e documentarista, che attraverso le sue parole e i suoi scatti racconta l’impatto che la violenza urbana, le gang e le politiche repressive per contrastarle, possono avere sulla vita delle persone, anche a migliaia di chilometri di distanza.
Concludono il focus sulle gang giovanili David C. Brotherton e Rafael Gude che insieme hanno condotto una ricerca etnografica e d’archivio sui fattori strutturali e culturali che hanno portato l’Ecuador a optare per una politica di inclusione sociale, legalizzando le gang. Nell’analizzare il successo di questa iniziativa politica e le ricadute positive che questa scelta ha avuto sulla società ecuadoregna a dieci anni di distanza, l’articolo di Brotherton e Gude sposta anche l’attenzione del lettore dall’analisi del fenomeno alla ricerca di risposte concrete che vadano al di là delle politiche repressive o del mero dispiegamento di forze di sicurezza, per adottare un approccio più trasformativo, facendo degli attori violenti e criminali i protagonisti di un più ampio processo di cambiamento sociale. Chiude questo numero di Human Security, Omar Degan, giovane architetto che ha deciso di mettere la sua passione al servizio del suo paese di origine, la Somalia, sottolineando come il ruolo degli spazi pubblici rappresenti un’opportunità che architetti ed esperti di pianificazione urbana dovrebbero sfruttare meglio per ridurre la disuguaglianza, mitigare la violenza e contribuire alla ricostruzione non solo degli spazi fisici, ma anche – e soprattutto – di quelli sociali in contesti delicati e complessi come quelli post-conflittuali.
- Guerra con un altro nome? La violenza urbana nel XXI secolo
Kieran Mitton - Interventi umanitari in contesti urbani: quali i presupposti?
Tommaso Messina - Le street gang come forma di radicalizzazione glocale
Fabio Armao - Gli spettri della Mara Salvatrucha 13: capire le paure e le percezioni della diaspora salvadoregna
Donna De Cesare - Legalizzare le gang per ridurre la violenza in Ecuador
David C. Brotherton - Spazi pubblici come opportunità per ridurre conflitti e disuguaglianze in Somalia
Omar Degan
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Guerra con un altro nome? La violenza urbana nel XXI secolo
-
ANTIPIRATERIA, SICUREZZA PRIVATA E LIBERTÀ DI NAVIGAZIONE: ORIZZONTI DELLA SICUREZZA IN MARE
N. 5 (2017)Nel corso degli anni 2000, il deterioramento della sicurezza in mare ha suscitato sempre maggiori preoccupazioni, tanto a livello globale quanto nazionale. Il riemergere di fenomeni come la pirateria o l’acuirsi di tensioni geopolitiche rappresentano infatti sfide complesse, che richiedono risposte trasversali, coinvolgendo svariati attori a più livelli. Il numero di Human Security che va a chiudere il 2017 si occupa quindi di sicurezza marittima, offrendo ai lettori approfondimenti e analisi di questioni che raramente sono oggetto di dibattito pubblico, specialmente in Italia.
In apertura, Stefano Ruzza, docente di Conflitto, Sicurezza e Statebuilding presso l’Università degli Studi di Torino, sottolinea infatti come oltre ai problemi derivanti dalla crisi migratoria nel Mediterraneo, anche la pirateria ha avuto implicazioni significative – e talvolta non scontate – per i cittadini “a terra”. Le missioni militari come EUNAVFOR “Atalanta” o NATO “Ocean Shield”, pur avendo svolto un ruolo indispensabile, da sole non sono state sufficienti ad arginare il problema ed è stato necessario introdurre, a livello internazionale, anche l’imbarco di team armati a bordo del naviglio mercantile.
L’Italia – così come altri paesi – ha dovuto quindi riadattare il suo approccio alle attività antipirateria. In particolare con la Legge 130/2011, anche l’Italia ha introdotto la possibilità di imbarco di team armati su navi mercantili, rispondendo alle sollecitazioni provenienti dalla propria armatoria. Ed è proprio Luca Sisto, vicedirettore generale di Confitarma, a portare avanti la riflessione sulla specificità del caso italiano nell’impiego di personale armato, militare o privato, quali team di protezione a bordo dei mercantili. Intervistato da Ruzza, Sisto delinea l’evoluzione e le problematiche del panorama legale e istituzionale italiano in materia partendo dall’esperienza diretta di Confitarma e dal ruolo che l’armatoria italiana ha avuto nella creazione del modello “duale” previsto dalla Legge 130.
Conclude il focus sulla pirateria l’articolo seguente, a firma di Vincenzo Pergolizzi e Esther Marchetti che danno voce a un altro stakeholder di spicco: Metro Security Express (MSE). Primo Istituto di Vigilanza italiano ad aver ottenuto la licenza per effettuare servizi di antipirateria marittima, MSE ha dovuto affrontare e superare svariati scogli di ordine logistico, amministrativo e burocratico. Nel loro articolo, Pergolizzi e Marchetti accompagnano il lettore attraverso le fasi necessarie per poter operare e contribuire a quella che gli autori stessi definiscono “sicurezza partecipata” fra pubblico e privato.
Inserendosi nel più ampio dibattito sul ruolo del settore privato in ambito di sicurezza marittima, Eugenio Cusumano, docente di relazioni internazionali e studi europei presso l’Università di Leiden, sposta l’attenzione sulla questione spinosa della gestione dei flussi migratori, analizzando come la maggiore partecipazione di organizzazioni non governative nelle operazioni di salvataggio in mare abbia consentito un maggiore coinvolgimento delle aziende di sicurezza privata nella gestione della crisi libica, non senza criticità.
Come già accennato, la dimensione marittima della sicurezza è all’ordine del giorno anche nell’agenda internazionale. Chiude pertanto il quinto numero di Human Security un approfondimento di stampo più prettamente geopolitico sulla libertà di navigazione, affrontato da prospettive diverse da Marco Giulio Barone e Simone Dossi. Il primo, analista de Il Caffè Geopolitico, si concentra sulle sfide poste dalle bolle di interdizione A2/AD alla capacità degli Stati Uniti di porsi come garanti della libertà dei mari. Simone Dossi, ricercatore e docente presso l’Università degli Studi di Milano, rovescia la prospettiva osservandola dalla posizione dell’altra grande potenza, la Cina, che, pur interessata allo sviluppo di sistemi A2/AD, dal venire meno della sicurezza della navigazione commerciale ha certamente molto da perdere.
- La risposta italiana alla pirateria somala
Stefano Ruzza - Intervista a Luca Sisto, Vicedirettore Generale di Confitarma
Stefano Ruzza - Antipirateria marittima in Italia: l’esperienza di Metro Security Express
Vincenzo Pergolizzi, Esther Marchetti - Liaisons Dangereuses: Crisi migratoria, ONG e sicurezza privata
Eugenio Cusumano - La potenza marittima cinese: minaccia o tutela alla libertà dei mari?
Simone Dossi
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- La risposta italiana alla pirateria somala
-

SICUREZZA UMANA OLTRE CONFINE
N. 4 (2017)Da qualche anno a questa parte “la crisi dei migranti” domina le testate giornalistiche e i media europei. Senza dubbio la gestione dei flussi migratori contemporanei è uno dei temi più salienti nelle agende politiche nazionali e internazionali. Le migrazioni sono però un fenomeno poco compreso. Come affermato dal sociologo olandese Hein de Haas, infatti, molti dei ragionamenti, delle discussioni e delle politiche in materia di migrazione sono formulati sulla base di falsi miti con conseguenze talvolta disastrose per gli individui che decidono per una ragione o per l’altra di lasciare la loro casa. Questo numero di Human Security tenta di superare questa impasse guardando ad alcune delle molteplici dimensioni e sfaccettature del fenomeno migratorio. Quando parliamo di “migrazione” facciamo riferimento a un aspetto quasi caratterizzante della vita umana. Da sempre, infatti, l’essere umano si sposta in cerca di nuove opportunità o per sfuggire alla povertà, al conflitto e a condizioni ambientali sfavorevoli. La peculiarità dell’epoca contemporanea è piuttosto rappresentata dagli sforzi dei singoli stati di regolamentare il movimento di persone all’interno e all’esterno dei loro confini. Sforzi che sempre più spesso sembrano stridere con il tema dei diritti umani e della protezione internazionale, come evidenziato da Michela Ceccorulli, docente e ricercatrice presso l’Università di Bologna, che nel suo articolo prende in esame le recenti proposte di riforma del sistema di asilo in Europa da una prospettiva di human security. Continua la riflessione sull’impatto delle migrazioni e delle politiche volte a gestirle Silvia Giletti Benso, già docente presso l’Università di Torino, che, con un taglio più antropologico, sottolinea come inquietanti meccanismi di dominio e controllo caratterizzino alcune fra le più battute rotte migratorie, causando livelli di violenza tali da trasformarle in “itinerari di morte”, tanto nel Mediterraneo quanto in Messico. Infatti, nonostante ci si concentri spesso esclusivamente sul continente europeo, la migrazione è un fenomeno globale che si declina in forme diverse in contesti diversi. L’articolo seguente, a firma di Nicholas Farrelly, Associate Dean del College of Asia and the Pacific della Australian National University, sposta l’attenzione sul Sud-est asiatico e in particolare sul Myanmar, paese di origine di milioni di migranti che, alla ricerca di condizioni di vita migliore, varcano i confini nazionali, affrontando situazioni pericolose e influenzando notevolmente l’economia della regione. Farrelly esamina anche la questione del ritorno dei lavoratori migranti in un contesto già di per sé contraddistinto da tensioni e violenze di lunga data. Anche il rapporto fra migrazione e sicurezza è controverso. Da un lato, i conflitti scatenano grandi ondate di migrazioni, dall’altra i flussi di rifugiati in arrivo rappresentano una sfida per l’accoglienza e l’integrazione. Si pensa spesso, infatti, che le migrazioni – e in particolare le diaspore – causino instabilità nei luoghi di insediamento o che addirittura stabiliscano o mantengano collegamenti con il “terrorismo internazionale”. Nel suo articolo Elise Féron, ricercatrice presso il Tampere Peace Research Insitute dell’Università di Tampere, sfida la linearità e l’automatismo di questo assunto, esaminando diversi fattori che contribuiscono alla definizione dell’identità politica delle diaspore generate dai conflitti. Segue un articolo di Claudio Bono, consulente dell’International Training Centre dell’ILO, che evidenzia come anche le vicissitudini storiche influenzino le politiche nazionali contemporanee in materia di migrazioni, specialmente in un paese come la Giordania che negli anni ha dovuto affrontare le criticità socio-economiche, politiche e di sicurezza date dall’impatto dei moltissimi migranti provenienti della turbolenta regione mediorientale. Ribadendo ulteriormente l’importanza di tenere in considerazione la complessità dei fenomeni migratori nella definizione di politiche adeguate, Lorenzo Nannetti, analista de Il Caffè Geopolitico, chiude questo numero di Human Security con una valutazione delle complesse dinamiche conflittuali, politiche, demografiche e ambientali che motivano la scelta di chi, nonostante i rischi e la forte deterrenza europea, decide di partire dall’Africa alla volta del Vecchio Continente.
- La revisione del sistema di asilo in Unione Europea e il concetto di human security
Michela Ceccorulli - Le frontiere: orizzonti di controllo, dominio e sofferenza nelle Americhe e nel Mediterraneo
Silvia Giletti Benso - Myanmar on the move: migranti birmani alla ricerca di migliori prospettive oltre confine
Nicholas Farrelly - La dimensione politica delle diaspore generate dai conflitti
Elise Féron - Giordania tra migrazioni e sicurezza internazionale
Claudio Bono - La mancata percezione delle reali dinamiche della migrazione
Lorenzo Nannetti
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- La revisione del sistema di asilo in Unione Europea e il concetto di human security
-
UGANDA E MALI: CONFLITTO E SICUREZZA IN AFRICA
N. 3 (2017)Per la sua storia di insicurezza diffusa, il continente africano è sempre stato sotto i riflettori internazionali. La narrativa dominante, tuttavia, tende spesso a concentrarsi su alcuni contesti piuttosto che altri e a trascurare il ruolo di individui e strutture sociali, fornendo una lettura parziale – se non addirittura fuorviante – dei conflitti e delle tensioni che affliggono la regione. Nel tentativo di contribuire a una riflessione più ampia, questo numero di Human Security è dedicato interamente all’Africa.
Il primo fronte di conflitto preso in esame è quello dell’Uganda in cui la guerra civile ventennale combattuta nel nord del Paese tra il governo e la guerriglia guidata dal tristemente noto Joseph Kony monopolizza l’attenzione dei media e della comunità internazionale. Benché meno famosa, anche la regione occidentale del Paese è teatro di scontri e conflitti ricorrenti che affondano le loro radici nel periodo coloniale. Apre questo numero di Human Security Cecilia Pennacini, docente di Antropologia Culturale all’Università di Torino e direttrice della Missione Etnologica italiana in Africa Equatoriale. Pennacini richiama l’attenzione sulla regione del Rwenzori, al confine con il Congo, descrivendo come tanto le scelte politiche coloniali quanto quelle recenti abbiano influenzato le complesse dinamiche identitarie nell’area, alimentando tensioni e sentimenti di odio. Segue un articolo di Stefano Ruzza, docente di Conflitto, Sicurezza e Statebuilding all’Università di Torino e membro della medesima missione Etnologica, che approfondisce il quadro aperto da Pennacini richiamando la storia delle insurrezioni nel Rwenzori e legandola alle attuali politiche identitarie ed elettorali, per spiegare i cicli di violenza che ne sono discesi.
Il secondo scenario analizzato è quello maliano, caratterizzato dal susseguirsi di scontri e violenze, colpi di stato militari e insurrezioni, specialmente nel nord del Paese. La duplice crisi del 2012 e la presenza di gruppi armati tuareg-jihadisti hanno riportato il conflitto in Sahel al centro del dibattito pubblico e delle attenzioni della comunità internazionale. Nonostante il sempre maggior coinvolgimento di attori esterni, i tentativi di risposta all’instabilità del Mali hanno fallito e il Paese rischia ancora oggi di trasformarsi in uno stato fallito. Caterina Pucci, analista de Il Caffè Geopolitico, traccia la storia del Mali a partire dalla sua indipendenza ed evidenzia come l’incapacità del governo e delle istituzioni di comprendere e gestire la complessità del territorio “umano” rappresenti da sempre un forte limite alla stabilità del Paese. L’articolo seguente, a firma di Edoardo Baldaro, dottore di ricerca presso la Scuola Normale Superiore, affronta la crisi del 2012 sfidando l’interpretazione dominante che vede il Mali come una “vittima” del terrorismo di matrice islamica e ponendo invece l’accento sulle dinamiche che hanno generato la rottura del patto sociale su cui si era retta la democrazia maliana.
Chiude questo numero di Human Security una riflessione di Gearoid Millar, docente di Sociologia presso l’Institute for Conflict, Transition, and Peace Research dell’Università di Aberdeen, sul fallimento delle istituzioni nel soddisfare le aspettative dei cittadini e offrire esperienze positive di giustizia e sicurezza. Fenomeno che, purtroppo, rappresenta una debolezza di molti processi di ricostruzione post-conflitto nel contesto africano odierno.
- I rischi dell’etnicizzazione nell’Uganda contemporanea. Il caso del Rwenzori
Cecilia Pennacini - Manipolazione delle identità e mobilitazione spontanea: la persistente guerra a bassa intensità nel Rwenzori
Stefano Ruzza - Mali: Risolvere un conflitto a partire dal territorio “umano”
Caterina Pucci - Le sfide irrisolte del Mali: comprendere cause e dinamiche del conflitto in Sahel
Edoardo Baldaro - Perché istituzioni di sicurezza efficaci non sono sinonimo di esperienza di sicurezza
Gearoid Millar
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- I rischi dell’etnicizzazione nell’Uganda contemporanea. Il caso del Rwenzori
-
HUMAN (IN)SECURITY E AMBIENTE
N. 2 (2016)Più di qualsiasi altro fenomeno, il cambiamento climatico attrae sempre più l’interesse del mondo accademico e di quello politico. Quest’anno lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ha inserito per la prima volta nel suo Yearbook un capitolo dedicato alla relazione fra clima e sicurezza, definendo il cambiamento climatico un “moltiplicatore di minacce”. Sulla stessa linea, Charles Geisler, Professore Emerito della Cornell University, apre questo numero di Human Security esplorando le connessioni fra cambiamento climatico, violenza e sicurezza umana nel contesto africano. Segue un articolo di Teemu Palosaari, ricercatore al Tampere Peace Research Institute (TAPRI), in Finlandia, che introduce il “paradosso Artico” e la questione controversa dell’interrelazione fra presenza di risorse naturali e conflittualità.
La sicurezza umana è infatti indissolubilmente legata tanto ai cambiamenti ambientali quanto all’accesso alle risorse naturali. L’acqua è stata definita l’oro blu e il petrolio del 21° secolo e indicata come la risorsa naturale che nei prossimi decenni potrebbe calamitare tassi di conflittualità interstatale tali da scatenare il terzo conflitto mondiale. Parallelamente a un’accresciuta politicizzazione dell’acqua, tanto a livello domestico, quanto sul piano internazionale, si è sviluppato dunque un intenso dibattito in cui si sono affermati concetti quali idropolitica o diplomazia dell’acqua. Il primo dei pezzi proposti sul tema, a firma di Andrea Martire, analista de Il Caffè Geopolitico, offre una panoramica e breve analisi delle situazioni più rappresentative di conflittualità, reale o potenziale, sulla gestione delle risorse idriche fluviali a livello internazionale. A seguire, Gabriele Giovannini, dottorando presso la Northumbria University, propone un focus più specifico e dettagliato sulle dinamiche di conflitto e cooperazione tra paesi rivieraschi a monte e a valle del fiume Mekong partendo dal caso della diga di Xayaburi.
A chiudere, due articoli incentrati sulla città intesa come un ambiente multi-dimensionale che influenza e condiziona la sicurezza umana. Annalisa De Vitis, analista de Il Caffè Geopolitico, evidenzia come la portata e la velocità dei processi di urbanizzazione compromettano la capacità di alcune città di garantire livelli adeguati di human security. I membri del gruppo Architetti Migranti, invece, presentano alcune delle riflessioni emerse della loro ricerca nella città di Tigre, a nord di Buenos Aires, dove percezione di insicurezza e massificazione del lusso hanno plasmato i modelli di sviluppo abitativo urbano, dando vita al fenomeno delle città privatizzate che, oltre a inasprire le disuguaglianze sociali, hanno un notevole impatto ambientale.
- Cambiamento climatico e (in)sicurezza umana in Africa
Charles Geisler - Cambiamento climatico e risorse naturali nell’Artico
Temuu Palosaari - Il conflitto idrico nelle relazioni internazionali: la gestione delle acque comuni a più paesi
Andrea Martire - Conflittualità e cooperazione lungo il Mekong: il caso della diga di Xayaburi in Laos
Gabriele Giovannini - Human security e sviluppo dell’ambiente urbano
Annalisa De Vitis - L’impatto ambientale del recente sviluppo abitativo urbano argentino, tra barrios cerrados e villas. Il caso del partido di Tigre
Francesca Ronco, Corinna Di Franco, Alessandra Platania, Riccardo Tognin, Ruth Savio
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Cambiamento climatico e (in)sicurezza umana in Africa
-
RIPENSARE LA SICUREZZA GUARDANDO AL CONFLITTO
N. 1 (2016)Il conflitto è l’attività umana che investe più profondamente di qualunque altra le molteplici dimensioni dell’esistenza di chi vi è coinvolto: dalle idee di sé e dell’altro, all’integrità fisica e morale, passando per la disponibilità delle risorse essenziali alla sopravvivenza e dello spazio fisico necessario a renderla materialmente accettabile. Il modo e la misura in cui ciascuna di queste è toccata finisce, a sua volta, per influenzare la dinamica del conflitto.
La riflessione più immediatamente accessibile al pubblico italiano su questo fenomeno richiama tuttavia l’attenzione principalmente su due aspetti: il commercio delle armi e le azioni compiute dai governi – direttamente coinvolti o terzi – nello sforzo di soffocarlo, contenerlo, superarlo. Per quanto importanti, questi elementi costituiscono soltanto una parte del quadro che non ne può rendere l’insieme.Human Security (HS) si propone di favorire una migliore comprensione del conflitto adottando la prospettiva della sicurezza umana. La human security richiama infatti l’attenzione sul ruolo giocato dagli individui e dalle strutture sociali in cui essi vivono e operano: fattori oggi posti al centro della loro riflessione anche dagli attori tradizionalmente più interessati, i militari, attraverso il concetto di human terrain.
L’intento di HS è fornire ai suoi interlocutori – professionisti esperti o semplici interessati – una lettura dei conflitti contemporanei che permetta di coglierne genesi, sviluppi e prospettive di trasformazione, nella logica appunto della conflict transformation. Con rigore, ma con uno stile chiaro, asciutto e puntuale, HS propone i risultati della miglior ricerca prodotta in questo campo a livello nazionale e internazionale, curando in particolare le indicazioni di policy.
- Ripensare la sicurezza guardando al conflitto
Stefano Ruzza, Giorgia Brucato - Rinnovare la conflict analysis
Lorraine Charbonnier - Lo human terrain nelle operazioni militari
Maurizio Sulig, Maria Adelasia Divona - Pace e insicurezza nella vita quotidiana: il progetto “Everyday Peace Indicators”
Roger Mac Ginty, Pamina Firchow - Il problema della percezione dell’altro e il caso Ucraina
Lorenzo Nannetti - Il fattore umano nel decision making
Marco Giulio Barone
Il PDF completo del numero è disponibile sul sito del Torino World Affairs Institute (T.wai).
- Ripensare la sicurezza guardando al conflitto