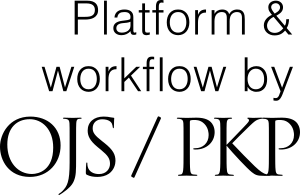Il futuro del peacebuilding e il ruolo dell’Italia
Abstract
Dall’inizio degli anni duemila, il peacebuilding è un settore in espansione a livello internazionale, con interventi posti in atto da organizzazioni governative e non, così come da realtà associative locali e istituti confessionali. In parallelo alla sua istituzionalizzazione a livello internazionale, gli ultimi tre decenni sono stati anche caratterizzati da un dibattito accademico intorno a questo concetto. Concepito originariamente dalle Nazioni Unite nel contesto degli sforzi di recupero post-conflitto per promuovere la riconciliazione e la ricostruzione, il termine peacebuilding ha progressivamente assunto un significato più ampio. Infatti, il peacebuilding fa oggi riferimento agli interventi volti a consolidare la pace in un mondo caratterizzato da crescenti complessità, focalizzandosi attraverso strumenti civili sulle problematiche strutturali e le relazioni di lungo termine tra i contendenti.
A livello italiano, il peacebuilding rimane piuttosto marginale. Da un lato, ci sono le istituzioni politiche – dai ministeri alla classe politica – che non riescono o non vogliono dare piena cittadinanza istituzionale al peacebuilding. L’Italia preferisce così essere tra i primi donatori del Peacebuilding Fund delle Nazioni Unite, ma non ha, per esempio, un ufficio e personale di riferimento presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che si occupi di questo tema. Un approccio che ricorda quello della Farnesina sulla cooperazione allo sviluppo negli anni settanta, quando, in mancanza di una struttura politica di cooperazione, affidava i propri contributi alle organizzazioni internazionali. Dall’altro lato, ci sono le organizzazioni della società civile (OSC), che portano avanti alcune sperimentazioni e progetti sul campo, ma, in buona parte, faticano a dialogare regolarmente con le istituzioni politiche e a sistematizzare il proprio lavoro per renderlo migliorabile, replicabile e per farlo conoscere.
L’articolo introduttivo di Pauline Veron e Andrew Sherriff mostra con grande chiarezza i risultati dello studio condotto da ECDPM sul peacebuilding in Europa. Ne emerge come il peacebuilding negli ultimi 25 anni abbia reagito e si sia adattato ai cambiamenti globali. La cultura interna di ogni paese e la sua storia spiccano come fattori importanti nel definirne il maggiore o minore sostegno al peacebuilding. Questa è una delle ragioni per le quali la Svezia è un grande investitore, mentre la Francia appare nettamente meno interessata. Allo stesso tempo, i cambiamenti repentini degli ultimi anni, inclusa l’ascesa del populismo, possono creare cambiamenti significativi nelle traiettorie, in un senso o nell’altro. Anche l’Italia potrebbe quindi scuotersi dal suo torpore in questo settore, così com’è stato, almeno in parte, nell’ambito dello sviluppo. Di certo, a oggi spende un 3 per cento di quello che investe la Germania su peacebuilding e prevenzione dei conflitti. Qualche segnale in questo senso, insomma, non potrebbe che giovare alla politica estera italiana.
Fra le organizzazioni che sono attivamente impegnate nella stabilizzazione in aree di crisi e nella prevenzione dei conflitti a livello europeo occupa un posto particolare l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), che con i suoi 57 membri gioca un ruolo importante nell’assicurare stabilità e pace a più di un miliardo di persone. L’OSCE, operando in un’ottica di composizione non violenta delle crisi e di inclusività, è riuscita negli anni a rafforzare la fiducia tra gli stati membri e a farli convergere, seppur con difficoltà, su questioni prioritarie quali il terrorismo, i processi di democratizzazione e il controllo degli armamenti. In particolare, l’esperienza della Presidenza italiana dell’OSCE nel 2018 ha fatto intravedere la possibilità di un’azione ancor più incisiva a livello di intervento sui conflitti, e non solo di stabilizzazione degli stessi, disancorandola finalmente dal suo “destino di comprimario” ben evidenziato da Mario Alberto Bartoli. Interventi certo non facili anche per via di alcune problematiche strutturali che da sempre ostacolano l’operato dell’Organizzazione, prima fra tutte la regola dell’unanimità che non è di facile applicazione vista la grande eterogeneità degli interessi politici e geo-strategici dei diversi stati membri.
Per Amnesty, organizzazione impegnata da decenni su interventi di costruzione di una pace sostenibile che abbia al cuore il rispetto dei diritti umani, il peacebuilding è settore di intervento prioritario. Nel suo articolo, però, Emanuele Russo ben evidenzia i limiti della politica estera italiana e come il nostro paese rischi di diventare un attore sempre più marginale.
A livello strettamente nazionale, invece, il peacebuilding ha, come sottolinea Luisa Del Turco, “solide basi” dal punto di vista normativo e politico “per un significativo sviluppo”. Un peacebuilding, quello italiano, tradizionalmente più votato agli interventi “bottom-up”, essendo suo grande punto di forza “una società civile plurale e attiva, che trova origine e alimento in culture diverse, specie in ambito cattolico e progressista”. Le forze limitate e i pochi fondi, tuttavia, hanno fatto sì che il peacebuilding italiano si orientasse per lo più verso sporadiche iniziative di advocacy, lasciando in secondo piano l’intervento sul campo. Del Turco non nasconde tuttavia i numerosi ostacoli che impediscono una fioritura del settore presentando allo stesso tempo una serie di iniziative recenti che possono essere di aiuto, in particolare, per rafforzare una cultura di pace. Nonostante le problematiche di ordine politico, economico e culturale, l’approccio italiano al peacebuilding è riuscito comunque a distinguersi nel panorama internazionale, in modo particolare grazie alla recente sperimentazione dei Corpi Civili di Pace (CCP), composti da volontari pronti a operare in azioni di pace non governative in aree di (potenziale) conflitto e di emergenza ambientale.
L’esperienza dei CCP, importante novità nel panorama del peacebuilding, ha riscosso grande interesse nel contesto colombiano. Attraverso la sua testimonianza, Riccardo Toso mostra come l’Italia, seppur assente nel processo decisionale, abbia partecipato con successo al progetto di costruzione della pace portato avanti dall’ONG Progetto Domani: Cultura e Solidarietà (PRO.DO.C.S) con l’invio di volontari civili, parte del contingente dei Corpi Civili di Pace italiani. Un’esperienza positiva perché capace di destare curiosità nei locali grazie al coinvolgimento diretto dei volontari civili con i beneficiari del progetto in questione, che ha accresciuto il livello di fiducia nel progetto e, dunque, le possibilità di successo dello stesso. Un intervento di peacebuilding “dal basso per il basso”, da sempre punto di forza del peacebuilding “all’italiana”.
Nel complesso, quindi, in un quadro di forte mutamento globale, la politica estera dell’Italia appare un po’ intimorita e spesso caratterizzata da un approccio meramente di reazione e su canali predefiniti. Il peacebuilding e la prevenzione dei conflitti, benché ben presenti nelle istituzioni dell’Unione Europea e in molti paesi europei, rischiano di rimanere concetti vaghi e da tirare per la giacchetta quando serve. Questo settore, però, non può continuare a figurare in disparte, come un effetto cosmetico da richiamare all’occorrenza. Le istituzioni politiche fino a ora hanno tergiversato e hanno in buona parte ostacolato l’apertura di nuovi percorsi. Con qualche eccezione valida, come la discussione in corso sulle nuove linee guida della cooperazione italiana sul nesso umanitario, di sviluppo e di pace. Occorre quindi più coraggio e continuità per non rimanere indietro in questo settore della politica estera. E le OSC possono dare un contributo determinante attraverso sperimentazioni sul campo e un dialogo strutturato con le istituzioni politiche.
Published in:
Pubblicato
Fascicolo
Sezione
Licenza
Gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista;
- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista;
- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poichè può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata (Vedi The Effect of Open Access).