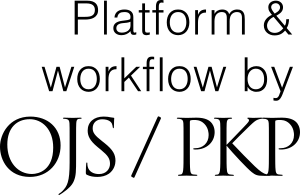Osservare il peacebuilding italiano con gli occhi dei suoi protagonisti
Abstract
Dalla fine della Guerra Fredda a oggi, il peacebuilding è divenuto prassi diffusa all’interno della comunità internazionale, tanto nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), quanto presso altri fora multilaterali e singoli stati. Il concetto fu coniato dallo studioso norvegese Johan Galtung per riferirsi alla costruzione e al sostegno di strutture sociali capaci di produrre e mantenere una pace sostenibile. Acquisito dalle Nazioni Unite all’inizio degli anni novanta, il termine peacebuilding ha trovato un’applicazione sempre più ampia, superando l’iniziale definizione di “ricostruzione post-conflitto”, e includendo oltre a quest’ultima, anche prevenzione e gestione del conflitto stesso e, sempre di più, cooperazione allo sviluppo. L’importazione del concetto di peacebuilding in ambito ONU ha riflesso il radicarsi della convinzione che pace e sviluppo siano due facce della stessa medaglia e che la comunità internazionale debba affrontare gli imperativi di sicurezza e sviluppo in maniera sinergica, attraverso politiche e programmi integrati.
Il 27 aprile 2016, l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno adottato due risoluzioni sostanzialmente identiche sul peacebuilding, concludendo la revisione del 2015 della cosiddetta “Peacebuilding Architecture” e reiterando l’impegno politico degli stati membri nel promuovere pace e sicurezza a livello globale. Le risoluzioni hanno introdotto il concetto di “sustaining peace” che, invece di ridefinire in toto il termine “peacebuilding”, ne amplia la portata, mettendo su carta quello che di fatto avveniva già, almeno in parte, nella pratica: il peacebuilding è una priorità durante tutte le fase del conflitto (e non solamente una volta cessate le ostilità) e, in quanto tale, deve avvenire contemporaneamente alle attività di assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo. Sulla base di questo nuovo quadro normativo, peacebuilding e sustaining peace sono quindi definiti come “un obiettivo e un processo per costruire una visione comune di società” che comprende attività volte a prevenire “lo scoppio, l’escalation, la continuazione e la recrudescenza dei conflitti”, intervenendo sulle loro cause profonde, assistendo le parti in conflitto per porre fine alle ostilità, supportando i processi di riconciliazione e gli sforzi per procedere verso la ripresa, la ricostruzione e lo sviluppo. Il sostegno alla pace è quindi concepito sempre più come un compito e una responsabilità condivisa del sistema delle Nazioni Unite e degli stati membri, nonché delle loro società nel loro complesso.
Facendo seguito a quelle che rischierebbero di rimanere semplici dichiarazioni d’intenti, nel suo Rapporto del 2018 sul peacebuilding, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha sollecitato la comunità internazionale a impegnarsi per un “quantum leap” o salto di qualità nel supporto – politico e soprattutto finanziario – alle attività di costruzione e sostegno alla pace. La decisione dei governi di rispondere ai conflitti violenti o alla loro minaccia, sostenendo il peacebuilding in maggior o minor misura, è una scelta – politica e burocratica – e, come tale, è influenzata da diversi fattori, che vanno al di là della mera volontà politica o della disponibilità di risorse (come sottolineato dallo studio Supporting peacebuilding in times of change effettuato da ECDPM nel 2018 e sintetizzato nell’articolo seguente firmato da Pauline Veron e Andrew Sherriff). Tuttavia, il ruolo di questi fattori e l’impatto che essi hanno sul comportamento dei governi e sulla loro capacità di rispondere all’appello del Segretario Generale non sono stati ancora oggetto di analisi approfondite.
Questo è particolarmente vero in Italia, dove le riflessioni più immediatamente disponibili al pubblico in materia di pace, sicurezza e conflitto si limitano a sporadiche notizie di geopolitica o – peggio – si declinano in sterile propaganda politica, peraltro con riferimenti scarsi o nulli al tema del peacebuilding. In Italia, quest’ultimo sembra trovare un suo spazio solo nei discorsi “introspettivi” di accademici, specialisti e tecnici, rimanendo ai margini del discorso pubblico e del dibattito politico.
Eppure, tanto la Costituzione italiana quanto la legislazione attualmente in vigore sulla cooperazione allo sviluppo riconoscono la promozione della pace e la prevenzione dei conflitti come obiettivi fondamentali e parte qualificante della politica estera italiana. L’Italia contribuisce attivamente alla definizione di agende e quadri normativi internazionali rilevanti per il settore del peacebuilding ed è uno fra i principali donatori del Peacebuilding Fund delle Nazioni Unite. Oltre al suo tradizionale impegno multilaterale, poi, l’Italia mantiene una solida presenza sul campo e ha un’esperienza consolidata in paesi fragili e in crisi attraverso le attività di una moltitudine di attori, governativi e non. Nei fatti, dunque, sembra esistere un “peacebuilding italiano”, seppur poco compreso e ancor meno valorizzato.
A fronte di queste considerazioni, questo numero di Human Security si propone di delineare i contorni degli sforzi italiani a sostegno della pace a partire dalla prospettiva di attori e mondi diversi, da quello dei think tank a quello istituzionale e diplomatico passando per quello delle organizzazioni non governative.
Pauline Veron e Andrew Sherriff, rispettivamente Junior Policy Officer e Head of Programme presso ECDPM, aprono questo numero di Human Security riassumendo i risultati del già menzionato studio sul supporto dei paesi europei al peacebuilding. Sulla base dell’analisi di Veron e Sherriff, gli autori dei sei contributi che seguono sono stati chiamati a riflettere sul caso italiano a partire dalle seguenti domande: 1) Quali sono i punti di forza e i limiti del peacebuilding italiano? 2) Perché l’impatto del peacebuilding italiano è relativamente modesto o percepito come tale? In assenza di una maggiore disponibilità di risorse, come si può migliorarne la resa, reale e/o percepita? 3) Quali tra i fattori individuati da Veron e Sherriff contribuiscono positivamente allo sforzo italiano di sostegno alla pace e quali negativamente? 4) Chi sono gli attori del peacebuilding in Italia e che cosa limita la sinergia tra di essi?
La prima a interrogarsi sul tema è Luisa Del Turco, Direttrice del Centro Studi Difesa Civile (CSDC) che nel suo articolo offre una panoramica del contesto normativo e politico-istituzionale in cui si inserisce il peacebuilding in Italia, concentrandosi sul valore aggiunto di una società civile, quella italiana, plurale e attiva, capace non solo di impegnarsi nel lavoro di pace, ma anche di organizzarsi e collaborare, dando vita a esperienze e sperimentazioni interessanti, come quella dei Corpi Civili di Pace (CCP). Fra i 500 giovani al servizio dei CCP c’è anche Riccardo Toso che in questo numero di Human Security offre ai lettori una riflessione sul particolare approccio italiano a sostegno della pace in Colombia, a partire dalla sua esperienza di volontariato nell’ambito di un progetto di peacebuilding sviluppato “dal basso per il basso”. L’ultima voce appartenente al mondo della società civile è quella di Emanuele Russo, Presidente di Amnesty International Italia, che ci mette in guardia sui rischi derivanti dall’eventuale indebolimento dell’Italia come attore chiave del peacebuilding internazionale a fronte di quello che Russo definisce un “progressivo scollamento del paese da quello che accade intorno a sé” e il conseguente allontanamento della politica italiana da una visione del mondo e una linea d’azione tradizionalmente “tracciata nel solco dell’approccio europeo ai diritti umani”.
Nonostante le spinte sovraniste e le dinamiche geopolitiche rappresentino – oggi forse più di ieri – un attacco frontale agli ideali dell’internazionalismo, l’Italia sembra mantenere la sua tradizionale propensione al multilateralismo. Come già accennato, il termine “peacebuilding” ha trovato il suo alveo istituzionale all’interno dell’ONU, l’organizzazione internazionale di riferimento per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello globale. Per poter riflettere sull’approccio italiano al peacebuilding per coglierne le caratteristiche distintive è quindi necessario volgere lo sguardo al ruolo dell’Italia in ambito ONU. L’Ambasciatrice Mariangela Zappia, Rappresentante Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a New York, fornisce una panoramica delle diverse declinazioni dell’impegno italiano nel contesto onusiano. La leadership italiana sotto al profilo della prevenzione dei conflitti, della costruzione e del sostegno alla pace si esplica anche a livello regionale, come sottolineato da Mario Alberto Bartoli, Capo del VI Ufficio (OSCE) della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Intervistato da Stefano Ruzza, il Consigliere di Ambasciata Bartoli racconta come la Presidenza italiana dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), estesasi lungo il 2018, sia riuscita a ricavare lo spazio politico per rafforzare l’impegno dell’Organizzazione nelle attività di prevenzione e mitigazione delle minacce alla pace e alla sicurezza, oltre che a promuovere stabilità in Europa orientale. Ciononostante, Bartoli evidenzia come promuovere gli sforzi a sostegno della pace di istituzioni più securitarie come l’OSCE rimanga un’operazione difficile. Una criticità, quest’ultima, che si riflette anche sul lavoro delle Forze Armate, che solo raramente vengono percepite come attività di peacebuilding, ma che, di fatto, possono contribuire alla sicurezza umana di individui e società in contesti conflittuali. Guardando al caso italiano, questo aspetto appare particolarmente penalizzante a fronte del ruolo positivo e da valorizzare delle Forze Armate, come si racconta nell’articolo scritto da Lorraine Charbonnier a partire da una conversazione con il Rappresentante Permanente italiano alla NATO, l’Ambasciatore Francesco Talò.
Quello che emerge con chiarezza dalle parole degli stakeholder coinvolti nella stesura di questo numero di Human Security è che il peacebuilding non è un settore sempre facile in cui operare. Nonostante le problematiche di ordine politico, economico e culturale, l’approccio italiano alle attività di costruzione e sostegno della pace è riuscito comunque a distinguersi nel panorama internazionale, come sottolineato anche nell’articolo di commento a firma di Valentina Bertolucci e Bernardo Venturi, rispettivamente Membro del Consiglio Direttivo e Direttore di Agenzia per il Peacebuilding (AP).
Una recente valutazione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) ha sottolineato come nonostante le crisi economiche e migratorie degli ultimi anni, l’Italia abbia mantenuto il suo impegno nella collaborazione allo sviluppo. Il 2020 necessariamente richiederà all’Italia, così come a tutti i paesi colpiti dal COVID-19, un ripensamento generale delle priorità e lo sviluppo di una visione per il mondo post-pandemia. Se è vero che molto potrebbe cambiare nel prossimo futuro, è anche tristemente certo che i conflitti e l’insicurezza che oggi affliggono molte società non spariranno. La speranza è, quindi, che le riflessioni contenute nelle pagine che seguono e il quadro di sintesi offerto in chiusura dagli autori di questo stesso pezzo introduttivo possano offrire spunti utili per iniziare un ragionamento più ampio, inclusivo e sistematico sul peacebuilding “made in Italy”.
Published in:Pubblicato
Fascicolo
Sezione
Licenza
Gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista;
- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista;
- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poichè può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata (Vedi The Effect of Open Access).