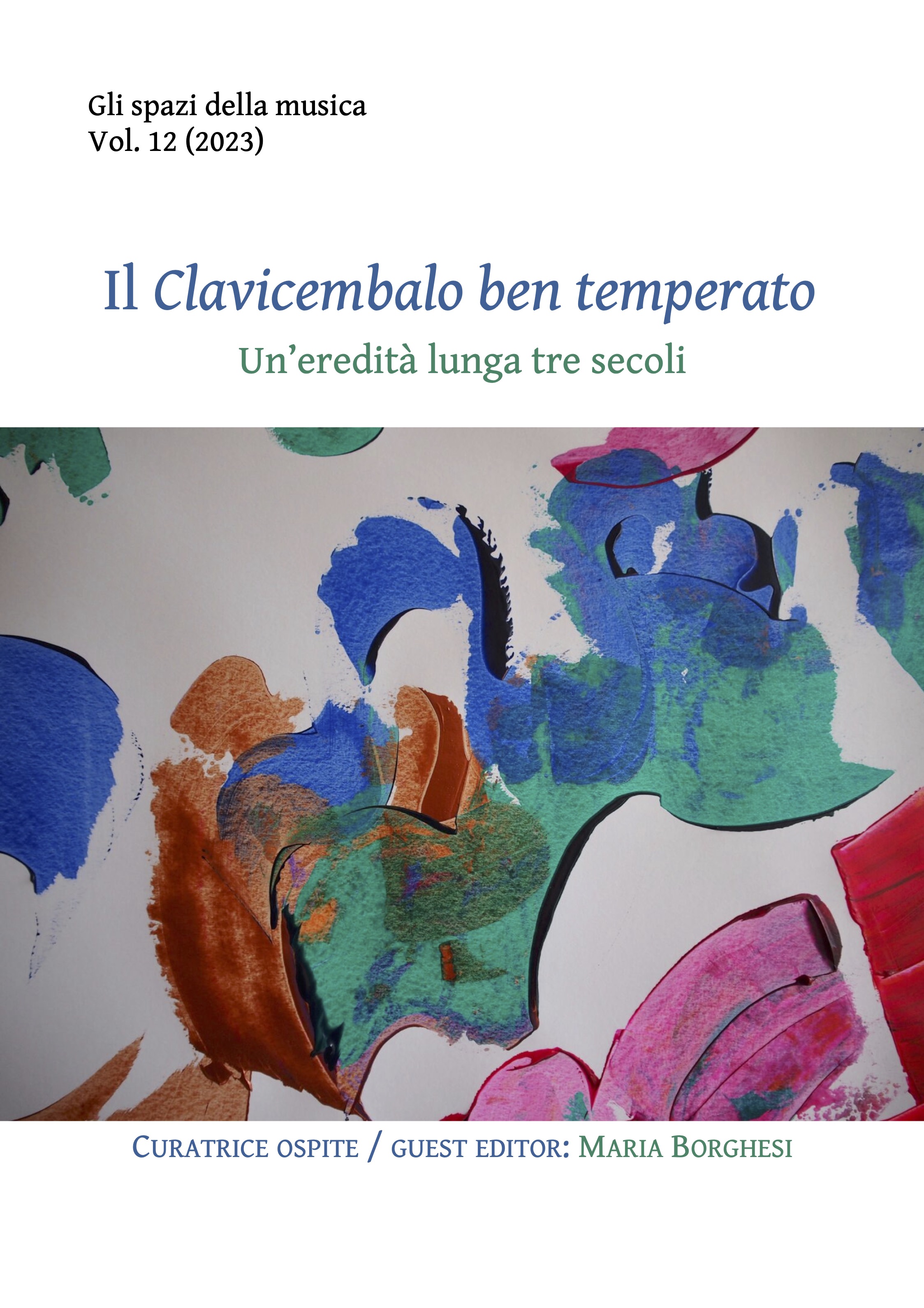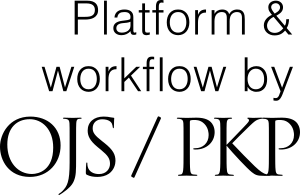«Eine solche Mannigfaltigkeit in den Schattierungen des Tons»
Ulteriori considerazioni su Johann Sebastian Bach e il clavicordo
Abstract
La predilezione per il clavicordo di Johann Sebastian Bach, riportataci da Forkel in un passaggio della sua biografia (frutto della frequentazione diretta ed epistolare con Wilhelm Friedemann, in qualità di suo allievo, e con Carl Philipp Emanuel) è stata messa in discussione da Wanda Landowska nel tentativo di rendere il clavicembalo Pleyel a lei intitolato un nuovo protagonista delle sale da concerto. Per la sua intima natura domestica il clavicordo non poteva prestarsi al rito del recital solistico che dall’epoca di Liszt prenderà il sopravvento. Il presente contributo vuole restituire al clavicordo il suo ruolo di primo piano nella storia della musica dell’età barocca, principalmente di area tedesca, cercando di chiarire le ambiguità legate all’uso comune della parola tedesca ‘Clavier’ per indicare il clavicordo (il più diffuso di tutti gli strumenti a tastiera) e di riflettere sulla destinazione delle opere tastieristiche di Bach. L’utilizzo del clavicordo (anche con pedaliera) come strumento principale per lo studio quotidiano e la preparazione degli organisti è testimoniato dal Quattrocento fino ad Ottocento inoltrato. Alla frequente presenza dei clavicordi nella letteratura, nell’uso didattico e domestico corrispose naturalmente un grande fervore costruttivo che coinvolse anche parenti e allievi di Bach. Con gli emigrati di lingua tedesca in Inghilterra Das wohltemperierte Clavier fu a lungo reso in inglese come The Well Tempered Clavichord. Raccogliendo i pionieristici sforzi di Pauer e di Hipkins, Arnold Dolmetsch iniziò a fabbricare copie di clavicordi a Londra nell’ultimo decennio del diciannovesimo. Molte fonti che caldeggiano l’uso del clavicordo sono prese in esame, da Kuhnau a Walther, da Händel (che già a Londra sconsigliava l’uso del clavicembalo e dell’organo per i principianti) a Mattheson. Un’interpretazione data dall’autore di un passaggio che coinvolge due maestri di cappella italiani che si recano ad ascoltare Bach al clavicordo conferma ulteriormente la predilezione del Kantor per il più espressivo di tutti gli strumenti a tastiera.
##submission.downloads##
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported. Tutti i diritti relativi a quanto pubblicato su «Gli spazi della musica», compreso il diritto di pubblicazione, restano di proprietà esclusiva degli autori.